Le Mummie della Sacra
All’ingresso della Sacra di San Michele, poco prima dello Scalone dei Morti, fa bella mostra di sé la riproduzione fotografica di un vecchio acquerello, in cui sono ancora visibili le celebri “Mummie” che si affacciano ghignanti sopra lo scalone, “abbracciate” ad una grossa croce. Furono immortalate anche in alcune rare foto, allineate contro il muro e protette da una grata. Oggi riposano sotto i gradini, ma erano una presenza importante e venerata.
La più curiosa menzione relativa alle mummie è quella contenuta in uno dei volumi della fortunata collana Murray's Handbooks for Traveller, dell’editore londinese John Murray, dedicato al Nord Italia e pubblicato nel 1847: “Questa scala è sostenuta da un enorme pilastro centrale: qua e là le rocce contro le quali l'edificio è costruito, appena fuori, e porzioni di sepolcri sono vagamente visibili. In cima c'è un grande arco, pieno di cadaveri essiccati. Fino a poco tempo fa, questi cadaveri erano collocati seduti sui gradini della scala; e quando si saliva alla chiesa, si doveva passare tra le orribili file di queste sentinelle. […] Da dove venivano i cadaveri, o perché erano collocati lì, non si può sapere: rispettati, se non venerati, i contadini li vestivano e li adornavano di fiori, il che deve averli resi ancora più orribili”.

Diverse sono le informazioni rimarchevoli che se ne deducono. Pare intanto che le mummie in origine non si trovassero negli archi che sovrastano lo Scalone, bensì sedute sui gradini ed era necessario muoversi tra di esse e aggirarle per poter salire fino al Portale dello Zodiaco.
Inoltre, erano vere e proprie reliquie, venerate dalla popolazione locale che provvedeva a “vestirle”, a mantenere in ordine i loro abiti e ad “adornarle di fiori”, un’usanza che senza dubbio proviene da un lontano passato.
La rimozione di questi corpi dai gradini poi, a quanto sembra, era recente. Ma un altro testo, edito nel 1822, Descrizione dei santuarii del Piemonte più distinti per l'antichità della loro venerazione e per la sontuosità dei loro edifizii opera adorna delle vedute pittoresche di ogni santuario dedicata alla s.r.m. di Carlo Felice re di Sardegna, volume primo, già registrava la presenza di cadaveri addossati ai muri e non seduti sui gradini: “Salendo le scale il passaggiero trovasi come atterrito alla vista di alcuni scheletri che, tratti dalle catacombe de’ monaci, furono colà rizzati lungo il muro, ed addobbati nelle più strane fogge; opera di qualche Pellegrino venuto negli ultimi tempi al Santuario”.
Anche questo autore, Modesto Vittorio Paroletti, indica chiaramente che la macabra esposizione di corpi “addobbati nelle più strane fogge” è una “opera recente”, ma non specifica in alcun modo qual’era la situazione precedente. Sostiene, però, che quei cadaveri erano stati esumati dal “sepolcro dei monaci”, la struttura ottagonale absidata ai piedi della Sacra, che viene indicata come tomba collettiva, nonostante a suo interno non siano state rinvenute sepolture. Il cimitero dei frati si trovava infatti intorno alla struttura che probabilmente fungeva da cappella funeraria.
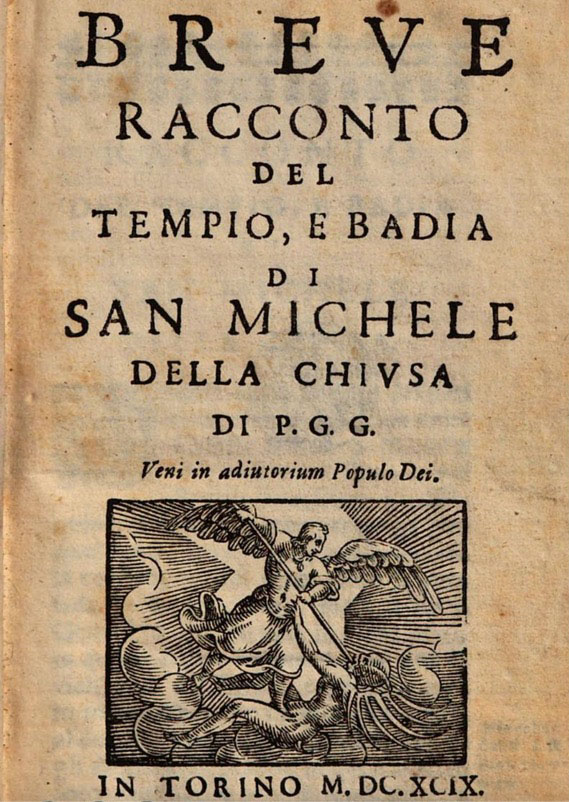
Risalendo tra i meandri del passato, un lavoro del 1699, scritto da Pier Giacinto Gallizia, Breve Racconto del tempio e badia di San Michele della Chiusa (in questo testo compare per la prima volta la leggenda della Bella Alda), a proposito dello Scalone si limita a descrivere “una gran scala che ha più di cento gradini, à lato di cui vedonsi parecchi sepolcri degli Abbati, e Monaci”.
L’inciso “e Monaci”, preceduto da una virgola, significa che si vedevano i monaci e i sepolcri degli abati, quindi le mummie c’erano e la loro presenza non era considerata così strana. Se fossero negli archi, sui gradini o presso entrambi non è dato saperlo.
Non c’é dubbio che questi corpi cadaverici provocassero forti emozioni in chi vi passava accanto. In Tradizioni italiane per la prima volta raccolte in ciascuna provincia dell'Italia e mandate alla luce per cura di rinomati scrittori italiani (1847), si racconta dello spavento di cui fu vittima un certo frate Bernardo, il quale sceso lungo lo Scalone per serrare il portone dopo il tramonto, rimase chiuso all’interno poiché il vento aveva bloccato i battenti del Portale dello Zodiaco. Mentre tentava disperatamente di attrarre l’attenzione dei confratelli, il malcapitato monaco cominciò a sentire e vedere un teschio che camminava sui gradini. Fu salvato dal padre superiore, accorso alle sue grida, il quale si fece coraggio e sollevò il teschio di scatto, facendo fuggire il topolino che vi nascondeva all’interno. Da questo aneddoto deriva il soprannome di “scala dei sorci” dato allo Scalone dei Morti.
Verso la fine del XIX secolo lo scrittore inglese Samuel Butler, nel testo Alps and Sactuaries of Piedmont and the Canton Ticino (1881) riprende le notizie del Murray's Handbooks for Traveller in Northern Italy aggiungendovi qualche nota di colore: “Con la porta della chiesa aperta, quale straordinario effetto si dovrebbe ottenere. Il manuale del Murray dice che gli scheletri, che si trovano ora sotto l’arcata, un tempo erano posti in posizione seduta sugli scalini e venivano incoronati di fiori dai contadini.
Immaginatevi quindi questi scheletri seduti fra fiori avvizziti e neve alla luce lunare o del crepuscolo mentre scende un ripieno d'organo (Handel, adagio dal quinto gran concerto)”.
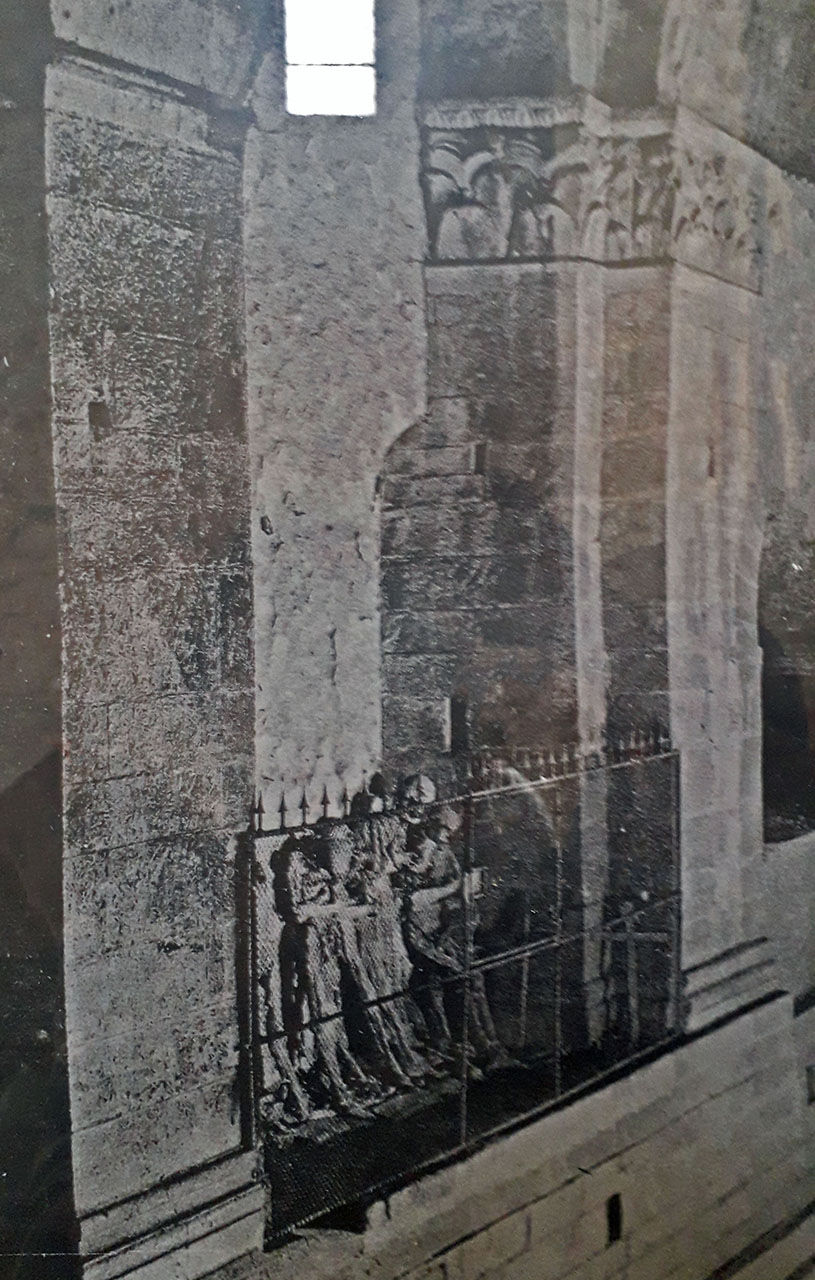
Inutile dire che, con l’esclusione di Butler, gli altri testi citati non riportano in alcun modo le fonti da cui hanno tratto le loro informazioni, le quali, pertanto, hanno un valore relativo e potrebbero essere “di prima mano” quanto ipotesi degli autori stessi intese per verità.
Forse è un dettaglio dei passaggi del Diario della Casa (Savoia) relativi alla definitiva rimozione delle mummie dallo Scalone dei Morti avvenuta nel 1936, ritrovati dalla Associazione Volontari Sacra di San Michele e pubblicati su Sacra Informa n.1 2013, che può illuminare, seppur flebilmente, il mistero di queste mummie.
17 marzo 1936: “Visita ai lavori dell'Illustrissimo Architetto Vittorio Mestruino che si ferma dal mattino fino alle ore 15 facendosi portare il pranzo da un albergo di S. Pietro. E' con lui l'impresario Sig. Maffioli. Chiamato dal suddetto Architetto, mi comunicò la decisione di trasportare le cosiddette mummie o scheletri, posti nella nicchia a destra di chi sale dello scalone, e trasportarli nel sepolcro dei nostri Padri e Fratelli, che si trova sotto lo scalone”.
18 marzo 1936: “Trasporto delle mummie (scheletri nella scala grande dei morti) nella tomba o camera mortuaria sotto lo scalone, già tomba dei PP. e Fratelli Rosminiani. Trasporto ordinato da S. E. Conte De Vecchi, Ministro della Educazione Nazionale. Nel mattino dalle ore 8 alle 10 e mezza due muratori prepararono un ponticello provvisorio per giungere al piano della larga nicchia, rimossero la griglia. Allora il P. Rettore, in cotta e stola nera, col chierico Giuseppe Pattarone, portarono Croce e aspersorio, salirono alle mummie, aspersile e recitate le preghiere rituali, cominciarono coi muratori a riempire di ossa, ossicini sparsi nella nicchia due casse e i muratori li trasportarono nella stanza mortuaria dei Rosminiani (i bocia o manuali scomparvero tutti, impauriti dalla vista dei cadaveri).
Sei cadaveri furono trasportati quasi intieri uniti i membri dalla pelle quasi incartapecorita: uno aveva le scarpe unite ai piedi, un altro scheletro era coperto da veste lunga con grembialino e mani giunte; quando tutte le ossa e scheletri furono trasportati in detta stanza mortuaria, uniti insieme, scese il P. Rettore in cotta e stola col detto chierico, asperse coll'acqua Santa, recitò le preci rituali e per le 10 e mezza la mesta funzione era finita. Requie e pace alle anime loro. Pax”.

L’abbigliamento di uno di quei corpi trovati pressoché interi è inequivocabile: la tunica lunga e soprattutto il grembiule sono il segno che il personaggio non era un uomo qualunque, bensì un vero e proprio “apprendista”. Il grembiule è infatti “il simbolo del corpo fisico, dello sviluppo materiale di cui lo spirito deve rivestirsi per prendere parte all’opera di Costruzione Universale” (Jules Boucher, La symbolique maçonnique, 1953), cioè del “vero lavoro” che porta l’uomo alla spiritualizzazione. E ciò si riferisce alla “massoneria” antica che, ben distante dalle caricature moderne senz’anima, era la Via Spirituale dei veri Costruttori di Cattedrali.
Esisteva un particolare tipo di grembiule, documentato almeno in Tibet e in Africa, ma probabilmente presente anche in occidente (ad esempio, ancora in epoca longobarda Paolo Diacono descrive l’uso particolare di teschi come coppe cerimoniali, testimoniando l’impiego delle ossa umane in certi ambiti rituali), che era realizzato con ossa umane intarsiate e il cui scopo era “associare i morti al lavoro spirituale che si intendeva compiere”.

Non si trattava di vana superstizione bensì di un rapporto di continuità e di aiuto tra vivi e morti che non si limita ad un laconico “memento mori”: “ricordati che devi morire”. Così, forse, si può spiegare la venerazione della gente semplice per le mummie disposte lungo lo Scalone e sotto gli archi della Sacra: erano le spoglie mortali di coloro che “erano andati avanti”, tracciando la strada per chi avrebbe voluto seguirli in quella particolare via spirituale, al di là della semplice vita cenobitica. I fiori di cui venivano addobbati quei corpi, infatti, sono essi stessi rappresentazioni delle anime dei morti e in particolare sono archetipi dell’anima. Quasi certamente quindi non erano fiori presi a caso quelli con cui venivano incoronati e dal colore e dalla specie di questi fiori potremmo trarre, semmai ci fosse possibile risalirvi, molte altre indicazioni.
Resta il mistero sull’epoca in cui questi corpi naturalmente mummificati furono accomodati sui gradini, sui motivi per cui si scelsero queste insolite posizioni e sull’identità dei personaggi che accettarono di fare delle loro membra, dopo la morte, queste sacre reliquie.
Si ringrazia anticipatamente chiunque volesse segnalare eventuali altri testi, fonti, ecc. per approfondire questo breve studio
BIBLIOGRAFIA
Pier Giacinto Gallizia, Breve Racconto del tempio e badia di San Michele della Chiusa di San Michele, Giov. Batt. Zappata, Torino, 1699
Modesto Vittorio Paroletti, Descrizione dei santuarii del Piemonte più distinti per l'antichità della loro venerazione e per la sontuosità dei loro edifizii opera adorna delle vedute pittoresche di ogni santuario dedicata alla s. r. m. di Carlo Felice re di Sardegna, volume primo, F. Reycend e compagnia, Torino, 1822.
Aa. Vv., Murray's Handbooks for Traveller in Northern Italy, John Murray, London, 1847
Aa. Vv., Tradizioni italiane per la prima volta raccolte in ciascuna provincia dell'Italia e mandate alla luce per cura di rinomati scrittori italiani, Volumi 1-4, Angelo Brofferio, Torino, 1847
Samuel Butler, Alps and Sactuaries of Piedmont and the Canton Ticino, David Bogue, London, 1881
Jules Boucher, La symbolique maçonnique, Dervy, Parigi, 1953
Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, Dizionario dei Simboli, Bur, Milano, 2001
Aa. Vv., Deposizione delle Mummie (scalone dei Morti) sotto lo Scalone nel sepolcro dei padri rosminiani, Sacra Informa n.1 2013, Avo Sacra, Sacra di San Michele, 2013
Storia dell'uomo che scopriva le tombe con il pendolino
Talvolta eventi fortuiti fanno riemergere dalle nebbie del passato storie dimenticate e curiose ma che meritano di essere raccontate anche se minacciano di sollevare dei gran polveroni. Quello che mi accingo a circostanziare è proprio uno di quei fatti, che lasciano interdetti per la stranezza di ciò che accadde e perché il testimone è il protagonista stesso, uomo di chiara fama e di indubbio prestigio, che non si fece scrupolo di pubblicare un libro sulla questione a proprie spese, affinché non se ne perdesse memoria.
Cosa pensereste se vi dicessi che Felice Pattaroni, «cavaliere al merito della Repubblica» e scopritore dell’ampia necropoli e dell’abitato del IV-V sec. a. C. di Pedemonte, presso Gravellona Toce (VB), individuò una per una le tombe (circa 126) vagando per la campagna con un pendolino per le mani?

Questo è quanto scrive a chiare e vivaci lettere lui stesso in un piccolo libro fatto stampare a sue spese, dal titolo «Come si diventa Radioestesisti», con il quale appunto rivendica anche il modo in cui giunse a fare le sue straordinarie scoperte.
«Tornato dall’Argentina, per ragioni di salute, mi dedicai, durante una lunga convalescenza, alle ricerche storico-archeologiche in Gravellona Toce (Novara) paese di residenza. Un eminente storiografo e scrittore Ossolano, il Cav. Enrico Bianchetti di Ornavasso, mio paese natìo, con la sua opera “L’Ossola Inferiore” mi aveva messo la pulce nell’orecchio circa l’esistenza in un luogo di un abitato di origine Gallo-Romana. Appassionato di ricerche mi avventurai attraverso le campagne […] Alla radiestesia neanche ci pensavo credendola un’arte creata dalla fantasia o frutto della superstizione».
In Argentina aveva incontrato alcuni «rastreadores» capaci di scovare grazie al loro «intuito» ladri e lestofanti in mezzo alla pampa. Ma pensava fossero invenzioni letterarie o poco più.
Dovette ricredersi. «Le sorprese, nella vita, non mancano mai: non è una sorpresa svegliarsi una mattina e trovarsi, poco dopo, di colpo, radiestesisti?».

E infatti, il primo maggio 1954 si imbatté, per puro caso, nella prima tomba. La riconobbe da alcuni resti di carbone emersi da una buca per lo spegnimento della calce. Fece fermare i lavori, avvisò la Sovrintendenza e un mese esatto più tardi, avendone avuta l’autorizzazione, cominciò a scavare. Mentre scavava, giorni dopo, vide gli operai, che stavano scavando le fondamenta di una casa moderna, tentare di scaricare un carico di pezzi di marmo. Fu improvvisamente sopraffatto dalla visione, proprio in quel punto, di una tomba, la più bella dell’intero complesso, come dichiarò, e fece in modo che il materiale finisse da un’altra parte, a costo di farsi prendere per pazzo.
«I polsi mi battevano forte, la testa mi bruciava e provavo delle vampe come quelle della menopausa femminile». Piantò un paletto per segnalare il punto e attese altri quattro mesi per arrivare a scavare fin lì. Rinvenne all’inizio soltanto un «pozzetto gallico»; tuttavia, giunto sul fondo, fece rimuovere una pesante pietra ed apparve una tomba: «Si trattava veramente della tomba più bella e più antica e, per di più di quella di un guerriero che ricordava la I invasione Gallica avvenuta appunto nel V sec. a. C. Finalmente potevo considerarmi soddisfatto e questo grazie alla “radiestesia”».

Durante la primavera successiva Pattaroni continuò le sue esplorazioni nella campagna gravellonese, fidandosi della sua sensibilità radioestesica. Un giorno fu avvicinato da una bambina di meno di due anni di età, incuriosita dal suo strano modo di distendere le mani. Così per non essere disturbato dalle sue continue domande la fece camminare davanti a sé e prese a chiederle, di tanto in tanto, secondo lei cosa c’era sotto la terra che lui indicava. La bambina rispondeva «i moot» (i morti) in alcuni casi, oppure «niente». Una volta esclamò perfino «I lomani!» (i romani).
Come poteva saperlo? Pattaroni tornò sul luogo la sera stessa e alla luce della luna, riuscì a localizzare con la massima precisione ben ottanta tombe: «Posi, ad ogni tomba, un contrassegno e, man mano la Soprintendenza sollecitava di mettere in luce un certo numero di tombe, venivano messe in luce e, alla presenza del Sovrintendente e di numerosi studenti, le tombe venivano aperte».
E così, proprio lui che non ci aveva mai creduto e si era sentito pazzo, per merito anche del fortuito incontro con un affermato neurologo originario di Varzo e specialista alle Molinette di Torino, il dott. Zanalda, che l’aveva incoraggiato a continuare a sperimentare la sua sensibilità, restituì alla sua città natìa un gran pezzo della sua storia: «Grazie alla radiestesia Gravellona Toce ha potuto fondare il Museo Storico-Archeologico, ricco di ben centocinquanta corredi tombali di epoca Gallo-Romana».
Con la fine degli scavi e la fondazione del museo, nel 1960, Pattaroni abbandonò l’attività di archeologo dilettante e si dedicò invece alla «medicina bioradiante», applicandovi la stessa tecnica radioestesica che si era sorpreso a esercitare istintivamente anni prima. Venivano pazienti da ogni dove, da tutta Italia e perfino dalla Francia e dalla Svizzera, ai quali non chiedeva mai nulla in cambio: «In questi lunghi anni di lavoro ho potuto curare parecchie migliaia di pazienti e, fra questi, trovai centinaia di collaboratori, non solo perché mi fornirono foglie, erbe, fiori, ma soprattutto perché, mettendosi nelle mie mani, mi fornirono una enorme quantità di cognizioni utilissime per la vita».

Certo queste sono informazioni che si preferisce tacere, allontanando la radiestesia da lui praticata dall’idea che le sue scoperte archeologiche ne fossero la sua prova prima, anche se i suoi libri più strani e fastidiosi, dedicati proprio all’argomento, non possono essere depennati dalla sua bibliografia.
E del resto, nessuno potrebbe immaginare quante altre scoperte scientifiche in ogni campo dello scibile umano, anche importantissime, siano state e ancora siano il frutto della sensibilità radioestesica di tanti medici, professori, archeologi, astronomi, speleologi, geologi e scienziati che la coltivano in gran segreto.
«Auguro a tutti i lettori di questa modesta opera di riuscire a diventare dei buoni radiestesisti o dei buoni guaritori, in modo che possano trovare, anche tra i travagli della vita, delle grandi soddisfazioni».
Tutti i brani citati provengono dall’opera «Come si diventa radioestesisti» di Felice Pattaroni, Omegna, 1977.
S’Acabbadora, il Répit e l'Acqua delle Undici e Mezza
«Il luogo del transito procura fatica,
faticosa è la via che vi conduce,
e in mezzo ci sono le acque della morte,
che sono inaccessibili» (Epopea di Gilgamesh 10, II, 24)
Chi è venuto prima di noi aveva un rapporto franco e certamente più sereno del nostro con la morte, ne conosceva ogni aspetto e si preparava attentamente a questo fondamentale incontro. C’era nell’antichità un’assoluta urgenza non solo verso il trapasso in sé, bensì verso il suo svolgersi nel migliore dei modi, quella «buona morte» ridotta oggi soltanto a propaganda materialista che rinnega tutta la profondità spirituale da essa sottesa.
Se restiamo prigionieri della concezione attuale non possiamo in alcun modo comprendere il rapporto tra gli antichi e la morte, la cui più alta e perfetta sintesi è forse la «sorella morte» di francescana memoria. Dobbiamo tornare ad abbracciarla e a sentirla come parte del fluire incessante e meraviglioso dell’esistenza, non come blocco fissato in un certo tempo.
In alcune zone d’Italia tra cui il Piemonte, si ricorda ancora l’usanza detta «acqua delle undici e mezza», generalmente ritenuta la richiesta del morente di un aiuto a «passare oltre» e quindi come una sorta di eutanasia. Una simile idea è con buona probabilità frutto del preconcetto e della mancanza di una vera prospettiva escatologica.
A rigor di logica, è difficile, per non dire impossibile, che un sorso d’acqua offerto al morente abbia il potere di provocare l’agognato distacco e di farlo passare oltre, a meno di immaginarne il soffocamento provocato dal liquido. L’acqua perciò potrebbe anche alludere a qualcos’altro. È la fonte della vita stessa, il primo elemento. E non bisogna dimenticare che per gli antichi nascere e morire erano due aspetti di uno stesso percorso, non l’inizio e la fine, ma due passaggi, tant’è che che nei testi arcaici si parla sia di «acque di vita» che di «acque della morte».
Il particolare più curioso è però l’orario cui quest’acqua è legata nella diceria popolare. Evidentemente simbolico e diverso dalla «undicesima ora» della parabola evangelica dei lavoratori nella vigna, esso corrisponde astrologicamente in occidente a 15° del Capricorno, che è l’istante del concepimento «spirituale», il fluire nuovamente nella vita. Non è difficile quindi riconoscervi la richiesta di aiuto per garantirsi una nuova nascita, morendo nel modo più armonico. Quanto all’acqua, essa è identificabile astrologicamente con quella che l’Aquario riversa dal vaso ed è proprio «nell’ora dell’Aquario» che avviene il concepimento fisico. Identiche conclusioni potrebbero essere tratte applicando i principi astrologici della medicina cinese arcaica.
Sembra quindi che questa «diceria», lungi dall’essere una generica speranza di aiuto «in extremis», sia invece una richiesta di «morire bene» per rinascere non in spirito, ma proprio in una nuova vita fisica, in modo coerente a ciò che prospettano le tradizioni relative alla «reincarnazione».
Dall’antichità ci sono giunte, seppure in forme degradate e spesso incomprese, molte forme di accompagnamento alla morte, di cui si ricordano soprattutto i particolari più truculenti e tragici. Un caso estremamente interessante e dibattuto è quello della «femina agabbadòra» sarda, sul quale vale certamente la pena di riflettere.
Acabbadora1 era il nome che designava chi, in ogni villaggio, dell’isola, interveniva appunto per accompagnare alla morte i moribondi che non erano in grado di lasciarsi andare. Per lo più erano donne a svolgere questo compito, ma non è escluso - sebbene incerto - che in qualche caso il ruolo possa essere stato ricoperto da uomini.

Non sembrano esserci dubbi sull’esistenza di queste figure, anche se non ci sono veri documenti che lo attestino, a parte i resoconti di alcuni studiosi e scrittori che non hanno mai rivelato le loro fonti2. Le prima notizie risalgono al padre scolopio Vittorio Angius3 che cita l’esistenza di «vecchie pazze» con mazzuoli, chiamate ad alleviare una morte difficile percuotendo la nuca o il petto del moribondo.
Secondo altri, invece, a partire dall’antropologo Francesco Alziator4, uno dei maggiori studiosi del fenomeno, lo strumento era un piccolo giogo che veniva posto sotto il cuscino del moribondo.
Sono diverse le testimonianze su come questa particolare usanza si svolgesse. Nessuno sapeva chi fosse l’acabbadora, perciò veniva «chiamata», quand’era necessario, lasciando il morente in casa solo e spalancando tutte le finestre e le porte al tramonto. Durante la notte la donna giungeva velata e in silenzio, rimuoveva lo scapolare, le medaglie e ogni altro oggetto religioso dal corpo del moribondo e dalla camera (se non avevano già provveduto i parenti); poi lo accompagnava a morire. E qui le versioni divergono. In qualche caso si racconta che gli premesse sul viso un cuscino fino a soffocarlo, molto più spesso pare gli assestasse un colpo secco sulla nuca o sulla fronte con uno speciale martelletto di legno, chiamato, secondo Angius5, «sa mazzocca».
Si insiste sull’alone macabro di questo lascito della tradizione, identificandolo come eutanasia. Eppure sono stati diversi i ricercatori che hanno sollevato dubbi in proposito. Gino Cabiddu6 sosteneva che le acabbadoras fossero leggende o che rappresentassero qualcosa di diverso da ciò che si voleva intendere e puntualizzava che, in ogni caso, le femine non ammazzavano le persone, si limitavano ad affrettarne la fine. Fausto Fresi7, concludeva che il loro compito era di «finire» cioè di portare alla fine, coloro che, pur soffrendo da lungo tempo «non riuscivano a morire», una condanna che la gente temeva più della morte stessa.

Recentemente Chiara Dolce e successivamente Italo Bussa hanno svolto meticolose indagini sul fenomeno giungendo a distinguere definitivamente la figura inverosimile e inventata della femina sanguinaria e omicida con il martello, da quella “magica” che potrebbe essere la “personificazione” di certe pratiche tradizionali effettive8.
L’esistenza di personaggi identici alle acabbadoras sarde, pur con altri nomi e con modalità differenti di azione è stata per altro attestata, anche con documenti storici, nell’Italia settentrionale e meridionale, oltre che in tutta la Francia, da Arnold Van Gennep9.
Particolarmente interessanti sono a tal proposito le testimonianze riportate da alcuni studiosi francesi a proposito della tradizione armoricana del «mel beniguet» o "maillet béni"10, il martello benedetto che aveva la stessa funzione attribuita a quello delle acabbadore sarde. Harmois11 riportava la storia di un abitante bretone che prestava il maglio ereditato dai suoi avi ai vicini di casa agonizzanti, affinché lo abbracciassero per scivolare più facilmente verso la morte e quella di un paesano di un villaggio vicino che era stato sepolto con un maglio fra le mani.
Jean-Loïc Lequellec, citandolo e rilevando l’usanza irlandese di deporre martelli nelle bare, affinché il morto potesse servirsene per aprire le porte del purgatorio, si chiedeva quindi se tali atti, a dispetto delle dicerie, non fossero in realtà assolutamente incruenti. E ancora, elencava, a sostegno di tale ipotesi, casi in cui il martello era a disposizione di un’intera comunità, conservato nella cappella del villaggio (come quella di Saint-Maltro presso Poulharff), in una cavità di un tasso presso la chiesa (come a Caurel) oppure appeso dietro la porta di ingresso del luogo sacro (ne parla John Aubrey intorno alla fine del 1600).

Di fronte a questi legittimi sospetti, non resta che analizzare attentamente gli elementi sopravvissuti all’oblio del tempo, per tentare di dirime la questione, a cominciare dall’etimologia del nome «acabbadora».
Si ritiene derivi dal castigliano «acabar» e dall’identico catalano «acabàr», che significano entrambi «finire, terminare» nel senso di «portare a compimento», così come le corrispondenti forme verbali sarde acabài/agabbare/accabbare12. Non ci sarebbe dunque alcun riferimento all’uccidere, bensì genericamente al porre fine. Tutto ha un inizio e una acabbadura (fine), anche la vita umana la cui morte è, appunto, l’acabbadura.
Poiché inoltre tali forme verbali hanno radice nel termine «cabu», capo, si potrebbe intendere che l’atto di concludere il tormento avvenisse attraverso la testa.
I due strumenti principali mediante i quali si compiva quest’opera pia erano il giogo e il martello, oggetto sacro il primo, temuto e misterioso il secondo. Il giogo, juale o juvale nei dialetti sardi, secondo il mito fu inventato, insieme all’agricoltura, dal greco Bouzyges, per ispirazione della dea Demetra. A questo personaggio è sovrapponibile il poco noto dio romano Sator, il seminatore, che compare anche nel celebre «quadrato magico». E Sator è Saturno (Saturno da satus, «semenza» e sero, «seme», ma anche saturare, cioè saziare). Questa preziosa informazione, è stata regalata al mondo dal noto esoterista Samuel Liddel MacGregor Mathers già nell'Ottocento, nella sua pur scarsa traduzione del quattrocentesco «The Sacred Magic of Abramelin the Mage», in cui, senza indugio, identifica l'enigmatico nome appunto con il dio-pianeta. Simbolo di unione con il divino, il giogo era considerato anche una rappresentazione della porta attraverso cui l’iniziato tornava dal mondo soprannaturale a quello terreno dopo l’esperienza «mistica». Più in generale è quindi il varco tra il mondo dei morti e quello dei vivi, quello attraverso cui si «torna indietro» che, di nuovo, richiama l’idea di una ciclicità dell’esistenza.
Sator-Saturno è, altrettanto, il dio del tempo e della morte, della distruzione necessaria che prelude a nuova vita. Il suo strumento è apparentemente la falce. In verità nei paesi celtici il dio della morte, Ankou o Ankow13, impugna un maglio. In Galles e in Bretagna era chiamato «piccolo martello della morte».
In tutte le tradizioni europee il termine che indica questo maglio allude a un oggetto con testa ovoidale di pietra e manico di legno. Non solo, tutti i nomi con cui viene indicato in occidente hanno la stessa radice, «mall, mael», il cui significato è molteplice: è il «martello di pietra» ma è anche il cielo, la folgore e di conseguenza è qualcosa che «taglia», separa, divide. Infine è qualcosa che viene lanciato.
Emblema di tutti questi significati è il martello del dio nordico Thor, il fulmine-ascia che è tagliente quando viene lanciato ed ha la forma di un maglio. Tale «strumento» è in grado di uccidere quanto di resuscitare (così capita con le capre magiche della tradizione norrena, Tanngnjòsrt e Tanngrisnir), di consacrare e di fecondare. Quest’ultimo attributo viene poi passato alla vergine cristiana, come indica una tradizione tedesca: «il fabbro lassù gettò il martello nel mio petto»14.
Il maglio è dunque l’attributo originale della «trista mietitrice», la morte, di cui è personificazione Saturno stesso. Separa il vivo dal morto, ciò che è degno di nuova vita da ciò che non lo è. Spezza i legami, anche quelli tra lo spirito e la carne, consentendo al moribondo di avviarsi verso il mondo dello spirito, da cui poi ridiscendere a nuova vita.
Il «màzzero» dell’acabbadora (traduzione in italiano ottocentesco del termine sardo «mazzocca», «mazzucca», «mazzolu» o «malteddhu») sembra essere appunto un bastone con un’estremità ingrossata e nodosa, riconducibile al tipo della «clava» saturnale.
Oggetti indubbiamente sacri entrambi - il giogo è la porta che viene aperta, il martello un ulteriore aiuto se ciò non dovesse bastare - sono certamente i protagonisti di una qualche tecnica rituale di cui non conosciamo più nulla se non i risvolti grotteschi dietro i quali è stata nascosta e poi perduta.
Ricorrendo però a conoscenze anche lontane, forse possiamo ricostruirne, almeno in parte, il funzionamento.
Il martello, come riportano le testimonianze relative alle acabbadore, serviva per percuotere la testa del defunto, la fronte, la nuca, «sopra l’orecchio»15 oppure le tempie. Non vengono però mai menzionati, neppure una sola volta, i segni e le tumefazioni che questa percussione ritenuta «violenta» avrebbe dovuto lasciare e che avrebbero certamente suscitato interesse in quanto «segni» dell’opera dell’acabbadora.
Forse i diversi punti indicati venivano toccati tutti insieme. La nuca corrisponde al passato, rappresenta l’eredità; dietro la nuca è localizzato il cervelletto o «cervello rettile», quello più «antico», istintivo. La fronte è invece il futuro, la visione di ciò che sta dopo. Il rito riservato al Papa defunto, che viene percosso sulla fronte tre volte dal camerlengo per constatarne il decesso, potrebbe esserne un applicazione e una sorta di privilegio: «aprire gli occhi» al pontefice morto sulla nuova vita che lo attende e quindi liberarlo con certezza dalle catene della vita terrena.
Quanto all’area delle tempie, in questa zona non ci sono ostacoli ossei e il cervello è indifeso. Già gli antichi greci sapevano che, se una freccia penetrava in quel preciso punto, avrebbe provocato la morte istantanea del malcapitato.
Ricorrendo ai principi della Medicina Cinese antica rileviamo che qui è localizzato il punto «straordinario» fuori meridiano di agopuntura denominato 2 Taiyang (che significa «Fegato»), utile per il trattamento di alcuni tipi di emicrania, della nevralgia del trigemino, della paralisi facciale, delle affezioni degli occhi, del mal di denti e noto ai praticanti di arti marziali perché, se percosso con forza, provoca immediata perdita di coscienza. Questo punto risulta inoltre quasi allineato verticalmente con i punti di agopuntura 23 TR (punta esterna del sopracciglio) e 1 Vb (punta esterna della piega della palpebra), entrambi correlati con le emicranie e i dolori oculari.
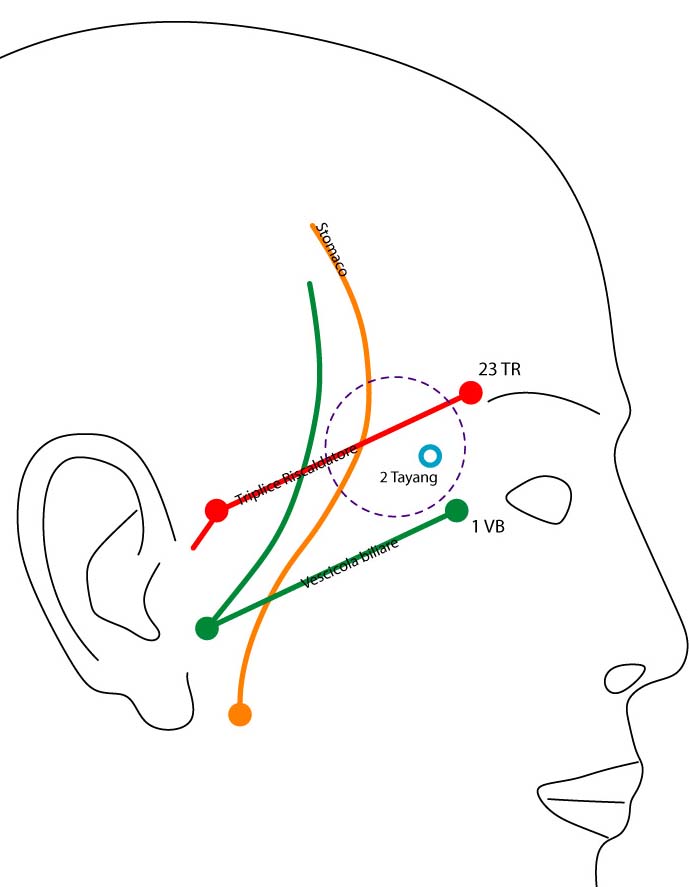
Proprio accanto a 2 Tayang c’é poi una sovrapposizione tra i percorsi dei due «meridiani energetici» Triplice Riscaldatore e Stomaco (accanto c’é anche quello tra Vescicola biliare e Stomaco). Tecnicamente attraverso il Triplice Riscaldatore (TR), il meridiano Milza-Pancreas (MP), che riceve il proprio ritmo dal meridiano Fegato (F), richiama l’energia vitale (il Q’i) proveniente dal meridiano Stomaco (S) e regolata dalle surrenali (che dipendono dal meridiano Reni - Rn).
Il permanere di energia vitale nel corpo è la causa della difficoltà a morire. Affinché il distacco possa avvenire correttamente, infatti, tale energia dovrebbe esaurirsi in armonia con l’esaurirsi delle funzioni biologiche. Ma un malanno, un incidente, una malattia, possono «inceppare» il meccanismo: il corpo è ormai prossimo alla morte, le attività fisiche sono ridotte al minimo, ma permane ancora troppa energia vitale che non è stata consumata. Lavorando in un certo modo sulle le tempie, sulla sovrapposizione dei due meridiani Triplice Riscaldatore e Stomaco e sul punto Taiyang 2 è perciò ipotizzabile che si possa provocare un doppi effetto: un’azione analgesica per alleviare le sofferenze e il completo richiamo dell’energia vitale da parte del meridiano Milza-Pancreas, che la dissipa bruciandola nel suo «fuoco». Questo, in corrispondenza dell’organo omonimo, è la vera e propria porta, quella che varchiamo nascendo e che riattraversiamo morendo. L’energia risucchiata alimenta il suo fuoco e apre i battenti. Così, in assenza di quell’energia che tiene legati l’anima e il corpo, il moribondo può finalmente passare oltre la porta. L’uscita dell’ultimo alito del Q’i dalla bocca, sempre correlata al meridiano Milza-Pancreas (è infatti la sua «Apertura»), era il segnale della «buona morte» dietro il quale forse si celavano le testimonianze di «soffocamento» con un cuscino.
In occidente, con l’avvento del cristianesimo, quella particolare energia della Terra che corrisponde all’organo e al meridiano Milza-Pancreas è stata personificata e occultata nella figura misteriosa della Maddalena. La sua identificazione con una meretrice o meglio con l’adultera dei vangeli, la traditrice, è spiegabile con la doppia natura del fuoco invisibile che brucia nella Milza: è portatore di vita (quando nasciamo, lo attraversiamo per discendere dallo spirito alla terra), quanto di morte (quando morendo ritorniamo dalla terra fisica al mondo dello spirito) ed è appunto «traditore» (può far del male) se non lo si sa usare correttamente.
Forse può essere ricondotta a questo fatto la diceria secondo cui, stando alle testimonianze, le acabbadore erano prostitute. Più spesso, però, le femine che svolgevano questo delicato compito erano le stesse levatrici di ogni paese: coloro che facevano nascere erano anche coloro che accompagnavano alla morte, in perfetta coerenza con la doppia funzione della Milza la quale è, per altro, uno dei due aspetti di Saturno, l’aspetto yin.
S’acabbadora, che impersonava il Saturno-yin, passivo e passato, impugnava il martello di Saturno-yang, il futuro e compiva dunque un’azione che li riunificava nel presente, consentendo al moribondo il passaggio che prima gli era precluso. Se questa ricostruzione è corretta, è assai verosimile che non si trattasse di una forma di «eutanasia» cioè atta a provocare in modo violento la morte, bensì di una tecnica che aveva il solo scopo di rimuovere gli ostacoli che impedivano al corpo di morire spontaneamente e all’anima di proseguire il suo corso.
Ma è indubbio che la distinzione fosse estremamente sottile e che un uso improprio di tale tecnica fosse evidentemente considerato pericoloso, al punto da rendere inevitabile una narrazione grottesca, folkloristica e lugubre dietro cui nasconderla per custodirla al sicuro.
Allo stesso tipo di necessità, sebbene in modo ancor più delicato e particolare, apparteneva di certo un’altra usanza arcaica, considerata tra le più longeve del cristianesimo, ma che ha radici molto più antiche: il répit o «ritorno effimero in vita dei bimbi nati-morti»16. Svolto anch’esso per lo più dalle levatrici, che ne conoscevano la pratica e i luoghi in cui poteva avvenire, viene descritto in ambito cattolico come un rituale di esposizione alla vergine o a certi santi affinché concedessero al mai-nato (impropriamente il nato-morto) di tornare brevemente in vita, per il tempo di un respiro, così da potergli impartire il Battesimo grazie al quale sfuggire al famigerato «limbus puerorum». La provvisoria sospensione della morte veniva annunciata da segni e manifestazioni visibili del corpo del bimbo, che prendeva a muoversi, arrossiva, perdeva liquidi ed esalava l’ultimo respiro. Nonostante l’avversione della Chiesa, questa usanza ebbe una diffusione enorme ed estremamente longeva in tutto l’occidente, esaurendosi solo nel XIX secolo.

Al centro del répit è chiaramente individuabile, rivolta ai bambini mai-nati, la stessa paura alla quale potevano rimediare le acabbadore. La preoccupazione delle madri e dei parenti infatti non era tanto che questi sfortunati fossero morti prima della nascita - un’eventualità purtroppo assai comune nelle epoche precedenti la nostra - quanto che non potessero morire nel migliore dei modi, rimanendo così in uno stato di sospensione e di tormento: non essere nati e quindi non poter davvero morire, impediva ai bimbi di essere rilanciati in una nuova vita, motivo per cui, anticamente, lungo il Nilo venivano portati al tempio della dea R(e)p(i)t, la signora delle molte vite e della rinascita eterna.
In Provenza, a Mougins, esiste ancora un Santuario del répit molto venerato (lo dimostra la quantità di tombe di infanti rinvenute), che è significativamente intitolato a Notre Dame de Vie, letteralmente «Nostra Signora della vita», non di una sola, ma di tutte le possibilità di vita.
E, del resto, nell’attuale Belgio, ad Avioth, dove c’é uno dei santuari dei ritorno effimero in vita più conosciuti e prolifici, ma anche nella regione circostante, i bambini mai-nati venivano chiamati aviots, dal Latino avivare (ridare la vita) e dal Francese raviver (ridare colore).
Poiché il termine répit comparve per la prima volta in Francia a Liesse, dove si venerava una «madonna nera» proveniente proprio dall’Egitto, è verosimile che quel rituale arcaico si sia perpetuato attraverso i secoli e le ere, assumendo il nome della divinità nilotica arcaica. Il significato di «répit» in lingua francese allude a una reiterazione, ad un nuovo tentativo che, evidentemente, non si riferisce allo stato di morte che viene sospeso e poi ripreso, ma a una nuova ripetizione della vita che i fanciulli non avevano avuto.
Ciò era possibile agendo in modo perfettamente speculare alle acabbadore, cioè eliminando gli ostacoli che avevano impedito la nascita. Anche in questo caso i meridiani coinvolti erano gli stessi: Triplice Riscaldatore, responsabile degli arrossamenti e del recupero di calore del corpo, che erano tra i segnali visibili di avvenuta «nascita» più frequenti; il meridiano Milza-Pancreas, responsabile dei sanguinamenti, del funzionamento del sistema circolatorio e di conseguenza della ripresa di tono muscolare, che venivano resi più evidenti praticando piccole incisioni sul corpicino; il meridiano Stomaco, responsabile delle evacuazioni di liquidi e sostanze corporali. Veniva inoltre posta teneramente davanti alla bocca dell’infante una piuma, per intercettarne il minimo alito, l’ultimo respiro, la fuoriuscita del Q’i dal corpo (la bocca è è infatti l’«Apertura» di Milza-Pancreas), che annunciava la «buona morte». A questo segnale, se non già prima, si procedeva in ambito cristiano al Battesimo. La «piuma» posta davanti alla bocca è probabilmente anche l’antichissimo retaggio egizio di quella con cui viene paragonato il cuore durante la «Pesatura delle anime», la Verità, Maat.
Il prodigio richiedeva diverse ore per compiersi, a volte giorni interi ed era accompagnato da specifiche litanie, tra le quali la più frequentemente recitata era la preghiera del Salve o Regina, in cui la Vergine viene definita «vita» e alla quale viene chiesto «mostraci dopo questo esilio Gesù», un potente riferimento all’esilio provocato dalla mancata nascita che poneva appunto il fanciullo in uno stato di sospensione.
È singolare che il prodigio del répit avvenisse non per intervento diretto attraverso un martello o un qualche strumento, bensì grazie all’azione di determinati luoghi, presso i quali lo sfortunato infante veniva esposto ai vati cui erano intitolati. Più spesso l’intercessore era la Vergine (meglio se nera o lattante) ma non mancano anche santi, da Saint Edme a Tommaso da Villanova, San Pantaleone, San Leonzio, Santa Rosalia, San Francesco di Sales e molti altri.
È probabile che il ricorso a un santo o alla Madonna dipendesse da una differenza nelle situazioni in cui il mai-nato poteva trovarsi. Ancora oggi si discute su quale sia il momento in cui l’anima penetri nel corpo tra il concepimento e il parto, che è considerato il limite ultimo. Ma si trascura il fatto che anche la discesa dell’anima non sia un attimo cristallizzato nel tempo, bensì un processo delicato che richiede tutti i nove mesi17. Se in un qualunque momento di questo periodo qualcosa non funziona, l’anima rimane inevitabilmente bloccata tra i mondi. Se riesce a «tornare indietro» (aborto) solitamente rimane accanto alla madre in attesa di un nuovo concepimento, per riprovare ad incorporarsi.
Ma se il processo si bloccava era necessario un intervento esterno per ripristinarlo. A volte era più «yang», di spinta (dall’altrove verso questo mondo), affidato ai «santi intercessori del répit»; altre volte era invece più adatto quello «yin», di «tiraggio», operato dalla Terra, la Grande Madre, personificata poi dalla Vergine. Dipendeva da quanta parte del cumulo egoico (dell’anima in divenire) si era incorporata e da quanta rimaneva ancora «dall’altra parte».
Ancora una volta è ben evidente l’azione di Saturno, nelle sue due polarizzazioni: Saturno yang personificato dai santi intercessori, che erano, con rare eccezioni, di sesso maschile; Saturno Yin celato nelle Vergini lattanti e nelle Madri Nere.
Rinascere al più presto in una nuova vita e proseguire nel ciclo delle esistenze è un’esigenza che l’uomo ha manifestato fin dai tempi più remoti. La conchiglia ne è la rappresentazione simbolica più antica. Per i Tuareg, che ne hanno fatto un ciondolo, l’ameruan, è anche la più preziosa. Le conchiglie venivano suonate in occasione dei riti di passaggio e durante le semine, in quanto segni propizi alla nascita, sia in senso spirituale che carnale, ma venivano anche collocate nelle tombe per accompagnare i defunti già nella preistoria. Così come la nascita «è resa possibile in virtù della stessa fonte inesauribile che sostiene la vita cosmica»18, allo stesso modo il defunto manifestava il mantenimento della sua unione con quella medesima forza che aveva alimentato la sua vita, in un eterno ciclo di ricorrenza.
NOTE:
1Per una trattazione esaustiva dell’argomento si rimanda a Pier Giacomo Pala, Antologia della Femina Agabbadòra, Galluras Editore, Luras, 2013.
2A onor del vero, pare che, in qualche resoconto di antichi sinodi diocesani, nei paragrafi relativi alle prefiche (le donne che accompagnavano con gemiti e lamenti i cortei funebri) esista qualche accenno alle acabbadore, che però non vengono mai indicate espressamente. Cfr. Pier Giacomo Pala, Antologia della Femina Agabbadòra, Galluras Editore, Luras, 2013 op. cit.
3Cfr. Vittorio Angius e Goffredo Casalis, Dizionario geografico storico statistico degli stati di S.M. il Re di Sardegna, vol. II, G. Maspero librajo e G. Marzorati tipografo, Torino, 1834-56.
4Cfr. Francesco Alziator, Il folklore sardo, La Zattera, Cagliari, 1957.
5Ibid.
6Cfr. Gino Cabiddu, Usi, costumi, riti, tradizioni popolari della Trexenta, Fratelli Fossataro, Sardinia, 1966.
7Cfr. Franco Fresi, Guida insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende e alle curiosità della Sardegna, Newton Compton, Roma, 1999.
8Cfr. Italo Bussa, L’accabadora immaginaria, Edizioni della Torre, Cagliari, 2015 e Chiara Dolce, La donna del capezzale: storia e antropologia dell'accabadura, Aquilegia, Desio, 2013.
9Cfr. Arnold Van Gennep, Les Rites de Passage. Étude Systématique des rites De la porte et du seuil, De l'hospitalité De l'adoption, de la grossesse et de l'accouchement De la naissance, de l’enfance, de la puberté De l'initiation, de l'ordination, du couronnement Des fiançailles et du mariage Des funérailles, des saisons, etc., Librairie Stock, Paris, 1924.
10Cfr. Jean-Loïc, Lequellec, Mégalithes et traditions populaires. La hache et le marteau de vie et de mort, Bulletin de la Société préhistorique française, tome 93, n°3, Société préhistorique française, Nanterre, 1996, pp. 287-297.
11Cfr. A.-L. Harmois, Inventaire des grandes haches en pierre trouvées en France, L'Homme Préhistorique, 6-8, Librairie Universitaire J. Gamber, Paris, 1928, p. 113-171.
12Cfr. Pier Giacomo Pala, Antologia della Femina Agabbadòra, Galluras Editore, Luras, 2013 op. cit.
13Cfr. Jean-Loïc, Lequellec, Mégalithes et traditions populaires. La hache et le marteau de vie et de mort, Bulletin de la Société préhistorique française, tome 93, n°3, Société préhistorique française, Nanterre, 1996, pp. 287-297 op. cit.
14Ibid.
15Cfr. Pier Giacomo Pala, Antologia della Femina Agabbadòra, Galluras Editore, Luras, 2013 op. cit.
16Per una trattazione completa dell’argomento si vedano Francesco Teruggi e Fabio Casalini, Mai Vivi, Mai Morti, Giuliano Ladolfi Editore, Borgomanero, 2015 e Fiorella Mattioli Carcano, Santuari à répit, Priuli&Verruca, Ivrea, 2009.
17Cfr. Livio J. Vinardi, Biopsicoenergetica I, Tecnipress, Lecce, 1986.
18Cfr. Mircea Eliade, Immagini e simboli, JacaBook, Milano, 1980, pp. 120-126.
BIBLIOGRAFIA
Angius, Vittorio e Casalis, Goffredo, Dizionario geografico storico statistico degli stati di S.M. il Re di Sardegna, vol. II, G. Maspero librajo e G. Marzorati tipografo, Torino, 1834-56
Alziator, Francesco, Il folklore sardo, La Zattera, Cagliari, 1957
Bussa, Italo, L’accabadora immaginaria, Edizioni della Torre, Cagliari 2015
Cabiddu, Gino, Usi, costumi, riti, tradizioni popolari della Trexenta, Fratelli Fossataro, Sardinia, 1966
Casalini, Fabio e Teruggi, Francesco, Mai Vivi, Mai Morti, Giuliano Ladolfi Editore, Borgomanero, 2015
Dolce, Chiara, La donna del capezzale: storia e antropologia dell'accabadura, Aquilegia, Desio, 2013.
Eliade, Mircea, Immagini e simboli, JacaBook, Milano, 1980
Fresi, Franco, Guida insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende e alle curiosità della Sardegna, Newton Compton, Roma, 1999
Harmois, A.-L., Inventaire des grandes haches en pierre trouvées en France, L'Homme Préhistorique, 6-8, Librairie Universitaire J. Gamber, Paris, 1928
Le Rouzic, Zacharie, Carnac. Legendes - Traditions, Coutumes et Contes du Pays, Imprimerie La Foye & J. De Lamarzelle, Vannes, 1934
Lequellec, Jean-Loïc, Mégalithes et traditions populaires. La hache et le marteau de vie et de mort, Bulletin de la Société préhistorique française, tome 93, n°3, Société préhistorique française, Nanterre, 1996
Mattioli Carcano, Fiorella, Santuari à répit, Priuli&Verruca, Ivrea, 2009
Pala, Pier Giacomo, Antologia della Femina Agabbadòra, Galluras Editore, Luras, 2013
Van Gennep, Arnold, Les Rites de Passage. Étude Systématique des rites De la porte et du seuil, De l'hospitalité De l'adoption, de la grossesse et de l'accouchement De la naissance, de l’enfance, de la puberté De l'initiation, de l'ordination, du couronnement Des fiançailles et du mariage Des funérailles, des saisons, etc., Librairie Stock, Paris, 1924
Vinardi, Livio J., Biopsicoenergetica I, Tecnipress, Lecce, 1986
Trovi tutte le informazioni sul sito ufficiale https://ilfilodelcielo.blogspot.com

Iscriviti subito alla newsletter
per ricevere tutti gli aggiornamenti sul libro,
i contenuti speciali che verranno pubblicati
e l'invito alle presentazioni di "IL FILO DEL CIELO"
Cosa aspetti? Iscriviti!
Teodora e i tre decani: il segreto celeste di Ravenna?
Il simbolo per eccellenza di Ravenna, che fu per tre volte capitale, è senz’altro l’Adorazione dei Magi, che compare in città almeno quattro volte: a Sant’Apollinare Nuovo la più celebre; a San Vitale sul sarcofago di Isacio (620-637 d. C.) e tra le vesti dell’imperatrice Teodora, nel mosaico a lei dedicato; a San Giovanni Battista su una capsella (reliquiario di marmo) dedicata ai Santi Quirico e Giulitta, della prima metà del V secolo (oggi è esposta al Museo Arcivescovile).
L’importanza di queste raffigurazioni per la cittadina ravennate è indubbia, ma non è fin in fondo chiaro perché essa fu scelta. Genericamente la si attribuisce alle simpatie monofisite dell’imperatrice Teodora, moglie di Giustiniano, sulla cui tunica i tre sacerdoti iranici compaiono e all’offerta dei “doni imperiali” compiuta all’indomani dell’elevazione di Ravenna a capitale dell’Impero Bizantino in occidente.

Inoltre non è facile stabilire quale delle immagini conservatesi possa essere eventualmente l’originale a cui le altre, sicuramente, si ispirano, essendo tutte precisamente modellate su uno stesso canone già ben consolidato.
Il mistero insomma rimane.
Forse una soluzione esiste, ma richiede di inoltrarsi in ambiti delicati e non sempre apprezzati dalla storiografia ufficiale. La vera natura dei Magi è il fulcro dal quale procedere. La tradizione è nota, i suoi risvolti e le sue inesattezze meno, a partire dalla “stella” che i tre avrebbero seguito. Essa infatti non compare nei testi più antichi che raccontano dei sapienti venuti da oriente a venerare il Bambinello. Il primo fra essi, il Vangelo di Marco, mette in bocca ad uno dei magi l’aver avvistato un certo “aester” in oriente in seguito al quale sarebbero partiti alla volta di Gerusalemme.
Gli apocrifi Protovangelo di Giacomo e il Vangelo Pseudo Matteo che da esso deriva, attribuiscono più precisamente alla venuta dei Magi il loro aver “consultato le stelle”. Sarà Origene, più tardi a consolidare definitivamente la tradizione della stella identificandola con una cometa.

Sembra che l’origine di questi Magi fosse iranica e che fossero esperti astrologi, ma notizie sulla loro reale esistenza non ce ne sono. Per uno di loro, Gaspare, è stata proposta, non senza qualche difficoltà, l’identificazione con il re indo-partico Gondophares il cui regno fiorì fra il 20 e il 46 d. C.
Nella tradizione copta etiope invece si ricorda Baldassarre, il re magio dalla pelle scura, identificandolo con l’imperatore Bazén, venerato come un santo presso il monastero di Debre Damo ad Axum.
Non c’è alcuna certezza neppure sul numero dei magi che visitarono il bambinello. Nei testi più antichi non vengono enumerati. La tradizione orientale indicava 12 magi, numero di natura astronomica e astrologica. Soltanto con quelli più tardi, la Caverna dei Tesori e la Storia della Vergine Maria, la loro quantità viene fissata a tre:
-
Baldassarre “Dio protegge la verità” portatore dell’incenso, abissino o di Nippur, 4°v
-
Gaspare “ispettore del tesoro”, portatore della mirra, persiano o di Meroa, 1°v
-
Melchiorre, “re della luce”, portatore dell’oro, ebraico o di Pa??, 7°v
E ancora, i tre adoratori sbalzati su una placca argentea del VIII sec. a. C. rinvenuta in Luristan, sacerdoti in adorazione del dio zoroastriano Zervan (Zurvan), il Tempo, sono stati riconosciuti come il possibile originale su cui furono modellati i Magi evangelici. Già Erodoto, del resto, riportava come il titolo di “magoi” fosse riservato proprio ai sacerdoti di Zarathustra.
Non possono certo sfuggire i continui riferimenti al cielo e alle simbologie zodiacali che emergono dal groviglio di tradizioni e leggende fiorite da sempre sulle figure di questi Re Magi. Che la chiave del mistero fosse nella stella, o meglio nelle stelle, forse l’aveva capito già Keplero, che nel XVII secolo aveva individuato un particolare fenomeno avvenuto nel 7 a. C. in grado di spiegare la cometa dei vangeli.

In quell’anno si era verificata una rara, se non rarissima, tripla congiunzione planetaria: ben tre pianeti, Marte, Giove e Saturno, si erano trovati ad una distanza angolare nel cielo così ridotta (meno di 5° di arco) da diventare indistinguibili e sembrare, insieme, un’unica, luminosissima stella nel cielo, formata da due pianeti quasi sovrapposti e uno nelle vicinanze, per tre volte nello stesso anno. I tre momenti furono il 29 maggio, il 01 ottobre e il 05 dicembre. Tutti e tre si svolsero in corrispondenza della costellazione zodiacale dei Pesci, al limite con quella dell’Ariete, quindi approssimativamente a oriente, proprio da dove si dice provenissero i Magi.
Le rappresentazioni, assai diffuse, del “Viaggio dei Magi” o della “Adorazione dei Magi” con due dei Magi affiancati o addirittura sovrapposti ed uno leggermente più discosto, potrebbero essere proprio una codifica di tali fenomeni astronomici e astrologici. Ne sono ottimi esempi quelli conservati nella Chiesa di San Biagio a S. Vito dei Normanni, la chiesa rupestre di Santa Cecilia a Monopoli o il bassorilievo del Sarcofago Albani, proveniente dalla Catacomba di S. Sebastiano a Roma, in cui uno dei Magi “osserva” gli altri due che sono in identica posizione.
Questa rara congiunzione, inoltre, era accaduta proprio in concomitanza con l’inizio di una nuova epoca precessionale, quella dei Pesci. Ma, questione ancor più sensazionale, i tre pianeti congiunti erano anche i reggitori e sovrani, i “decani” appunto, delle tre suddivisioni dell’epoca precessionale che si era appena conclusa, quella dell’Ariete.
Così Marte, Giove e Saturno - che erano appunto i tre “re” - nel momento più propizio, provenendo da direzioni diverse si erano “incontrati” proprio sopra Betlemme. La storia astronomica e astrologica corrisponde dunque magnificamente con quella tradizionale, svelando quella che potrebbe essere la vera natura dei Magi, personificazioni dei “decani” planetari.
Seguendo questi indizi astronomici a Ravenna, ci si imbatte in alcune coincidenze interessanti. La sua prima grande chiesa, San Martino in Ciel d’Oro (poi chiamata Sant’Apollinare Nuovo), fu fondata nel 505 sotto Teodorico, che aveva conquistato la città, già capitale del regno degli Eruli, facendone il centro dell’impero Ostrogoto. Non dovrebbe sorprendere che proprio nell’anno in cui fu gettata la prima pietra dell’edificio e precisamente il 23 luglio, si verificò una congiunzione tra Marte e Saturno (in Leone a 11°52 e 11°45 rispettivamente): non è infatti un mistero che nelle sette cristiane di matrice monofisita, come quella ariana, cui l’Imperatore apparteneva, i Magi rivestissero un ruolo molto importante.
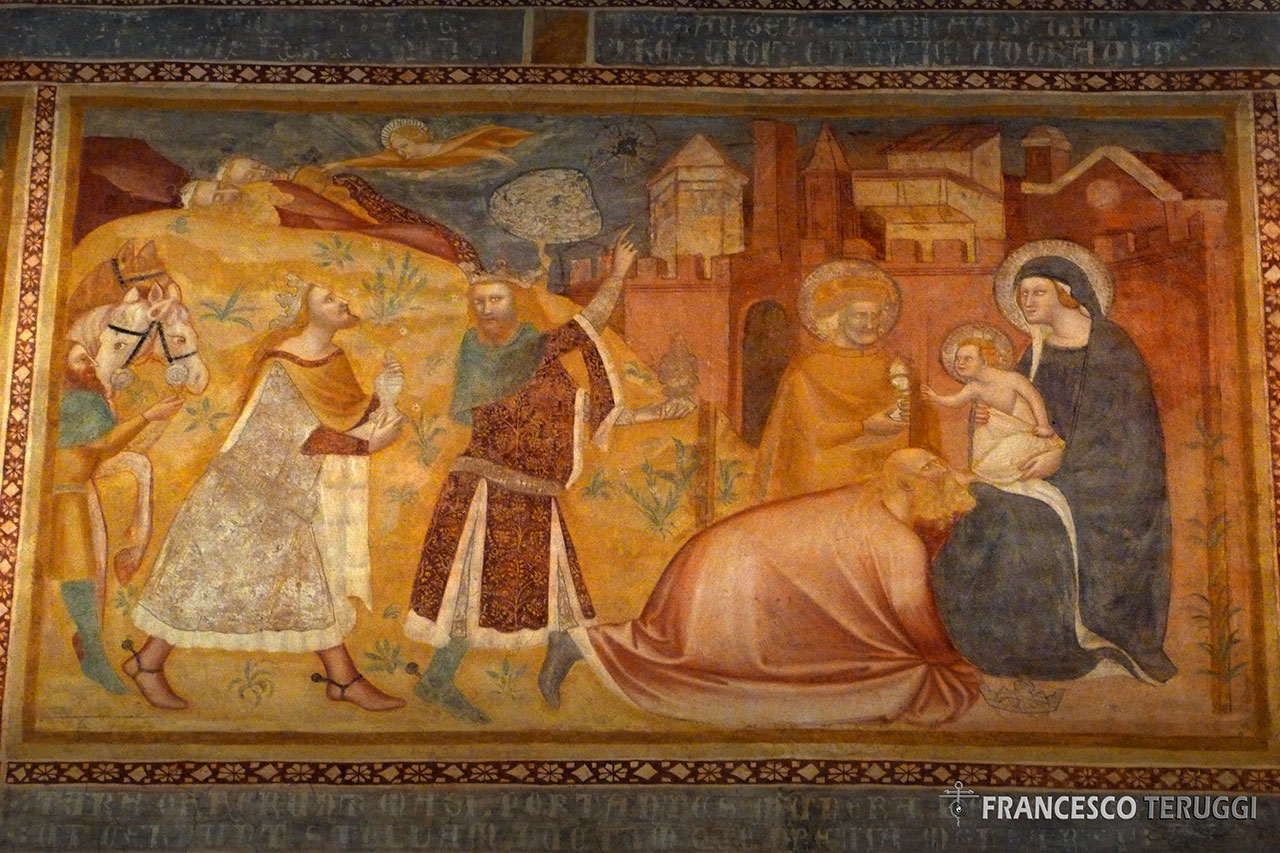
Ma quando Giustiniano la riconquista e ne fa la città principale dell’Impero Bizantino in Occidente nel 539, i Magi ne diventano il vero e proprio simbolo, visibile quanto nascosto. La riaffermazione della religione cristiana a Ravenna passa per la costruzione della maestosa chiesa di San Vitale, i cui lavori iniziano tra il 526 e il 530 d. C. Il 9 febbraio del 527 si verifica di nuovo una congiunzione legata ai Magi, quella fra Marte e Giove (in Aquario, a 12°44 e 12°37 rispettivamente).
Mentre fervono i lavori, poi, si da inizio anche all’edificazione di Sant’Apollinare in Classe, la cui prima pietra viene posata fra il 532 e il 536 d. C. circa e di nuovo, proprio in questo periodo si verifica una congiunzione tra due dei tre pianeti “esterni” del Sistema Solare, Giove e Saturno, il 9 maggio del 531 d. C. (in Gemelli, a 21°46 e 21°00 rispettivamente).
Di fronte a coincidenze così particolari, non è difficile ipotizzare che i tre edifici siano stati progettati per essere ciascuno la rappresentazione di uno dei re Magi:
-
San Martino in Ciel d’Oro (S. Apollinare nuovo): Saturno (con Marte), Baldassarre, 1° decano
-
San Vitale, Marte (con Giove), Gaspare, 3° decano
-
Sant’Apollinare in Classe, Giove (con Saturno), Melchiorre, 2° decano
La soluzione finale dell’enigma si trova a San Vitale, presso l’altare maggiore dell’edificio. In alto sulla destra uno statuario Giustiniano occhieggia impassibile verso l’abside. Di fronte, in un mosaico quasi speculare, compare invece Teodora, con le sue ancelle. Sulla sua veste si intravvedono tra le pieghe i tre Re, ritratti con il peso spostato in avanti mentre offrono i loro doni.
Se si osserva bene, si può notare che anche Teodora mima con le braccia la medesima postura porgendo la “cesta” identica a quella dei magi che porta tra le mani.

I tre sapienti, dunque, stanno tra le pieghe della veste dell’imperatrice così come, più in grande, si nascondono, visibilissimi eppure evanescenti “tra le pieghe” di Ravenna. Nonostante l’imperatrice sia indicata con il suo nome scritto in lettere scure, essa si presenta quindi anche come la personificazione della città. Ma le figure mistiche dei tre Magi, sottendono un significato che va ben oltre: Ravenna/Teodora racchiude i magi nella sua veste, come se ne fosse l’unione e si manifesta quindi come la nuova Stella destinata ad accendersi sul mondo. Ravenna bizantina “viene da oriente”, rispetto all’Italia, come i Magi rispetto a Betlemme.
Annuncia un nuovo “avvento”: ciò che, nelle intenzioni, doveva nascere era un nuovo Impero Romano, di matrice bizantina, il cui inizio corrisponde alla riconquista nel 533 di Ravenna, che diventa sede di governo in Italia.
Rimarrà un sogno. La guerra di Giustiniano contro i Goti durerà fino al 553, ma appena dopo l’Imperatore dovrà fronteggiare i Longobardi. La morte sopraggiunta nel 565 gli impedirà definitivamente di realizzare il sogno di un Impero Romano Universale.
Dell’aspirazione di Giustiniano di essere capo anche spirituale di questo Nuovo Impero, riunendo in sé entrambi i poteri, fu certamente “ambasciatrice” Teodora, le cui mire si spingevano ben oltre. Aveva “sposato” le idee monofisite mentre si trovava ad Alessandria, ben prima di conoscere Giustiniano e covava il desiderio di una restaurazione cristiana nel segno di tale dottrina. Arrivò perfino a ordire una congiura nel 537 per deporre il papa Silverio e far eleggere al suo posto il suo protetto Vigilio, diventato come lei monofisita. Il nuovo papa però si sarebbe presto rivelato un traditore e avrebbe innescato la lunga disputa detta Dei Tre Capitoli. L’imperatrice non portò a termine il suo disegno. Morì di malattia nel 548.
Di tutta la vicenda rimane, silenziosa testimone la Ravenna bizantina con i suoi tre luoghi mistici. Tra le mura di uno di essi si nasconde ben in vista l’ultimo indizio. Se si guarda per benino fra i piedi dei maestosi Magi di Sant’Apollinare Nuovo dai berretti rubicondi, si noterà – più di uno se ne è accorto – che spuntano alcune piantine in fiore. Sono due piante di Stramonio (Stramonium Datura), una di Giusquiamo nero (Hyoscyamus Niger, meglio conosciuto nell’antichità come Apollinarix) e una di Ladano (Ledum Palustre, Rosmarino selvatico). Sono tutte erbe psicoattive, inebrianti, capaci di provocare visioni. Figurano tra gli ingredienti fondamentali delle “pozioni” che si bevevano durante le celebrazioni dei Misteri eleusini, orfici, bacchici, dionisiaci, ma anche del leggendario “unguento delle streghe”. E sono tradizionalmente legate, rispettivamente, proprio a Saturno, Giove e Marte.
RAVENNA E I TRE DECANI è disponibile anche su Academia.edu in formato PDF
BIBLIOGRAFIA
C. Zaehner, Zurvain A zoroastrian Dilemma, Oxford 1955
A. Rucker, Zwei nestorianische Hymnen über Magier, in «Oriens Christianus» N. S. 10-11 (1920-1921)
J. Bidez e F. Cumont, Les Mages hellénisés. Zoroastre, Ostanès et Hystaspe d’après la tradition grecque, II (Les Textes), Paris 1938 (repr. 1973)
Alfredo Cattabiani, Florario: miti, leggende e simboli di fiori e piante, Mondadori, Milano, 1996
Marcello Mignozzi, Il Viaggio dei Magi: origine e fortuna di un motivo iconografico, Agiografia e Iconografia nelle aree della civiltà rupestre – Atti del V Convegno Internazionale sulla civiltà rupestre, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, 2013
L'ultima dimora degli enfants du répit
Quando un bambino mai-nato “tornava alla vita” per il tempo di un respiro in un santuario del répit e poteva ricevere l’agognato Battesimo, poteva finalmente essere sepolto “in terra consacrata”. Ma il dubbio verso questa antichissima quanto vituperata pratica, non proprio teologicamente limpida nell’ottica cristiana, spesso spingeva a cercare soluzioni particolari.
A Moustiers-Sainte-Marie o intorno a Notre Dame de Bettlerans (France-Comte) e a Notre Dame de Vie a Mougins così fu predisposto un cimitero apposito solo per quei fanciulli dall’enigmatico destino. Altre volte veniva allestita un’area dedicata nei cimiteri già esistenti, ove seppellire i corpicini in tombe individuali o in fosse collettive. In Valcamonica e non solo, questi spazi riservati avrebbero preso il nome di “Limbo”.
A Benoit-Vaux, addirittura, importante santuario mariano edificato su una sorgente miracolosa, le memorie di padre Gastellet riportano che un fanciullo battezzato dopo aver dato segni di ritorno in vita “fu interrato nella medesima cappella, ai piedi dell’altare della Concezione”.
Non sono usanze del tutto nuove, bensì permutate dalla tradizione: molti infatti sono i battisteri antichi sotto i pavimenti dei quali sono state ritrovate, occasionalmente e in numero limitato, sepolture di fanciulli, di infanti e di feti. In Italia settentrionale, tra la Lombardia e il Piemonte, si può citare ad esempio quello di San Filippo Neri a Busto Arsizio (VA), o quello di Settimo Vittone (TO) che, fra le tante inattese scoperte, insieme ad un antichissimo fonte battesimale sotto a quello attuale, ha restituito anche ossa certamente di bambini che qui vi furono sepolti.
Diversa, invece, era l’ultima destinazione degli sventurati che, nonostante l’esposizione ai piedi della Vergine o di uno dei santi “ausiliatori” del répit, non beneficiavano del prodigio e quindi non potevano ricevere il sacramento battesimale. Per loro, l’unica possibilità era quella di venir sistemati nella nuda terra “sotto la gronda” dei santuari, con la speranza che l’acqua piovana, divenuta lustrale per il contatto con il tetto dei santi luoghi, potesse in qualche modo donare ai bimbi mai-nati la liberazione dall’infausta condizione del limbus puerorum.
Con il procedere dei secoli e l’accanimento della Chiesa nei confronti della pratica, il répit fu alla fine sconfessato e proibito, così che tutti i bambini mai-nati furono destinati a non poter ricevere il battesimo e di conseguenza, ad una sepoltura al di fuori dei cimiteri, per la quale si rese necessario allestire ossari appositi, di solito proprio accanto ai battisteri.

Chapelle Sainte-Christine, Viserny
A spiegare incidentalmente come possa essersi verificato questo delicato passaggio è il noto studioso francese del fenomeno, Jacques Gélis il quale, in un suo articolo del 1981 cita il caso della Chapelle Sainte-Christine di Viserny, non lontano da Semur-en-Auxois (Borgogna/Franca-Contea). In questo edificio sacro esiste ancora, di fianco al fonte battesimale, un’apertura sul pavimento attraverso cui si accede ad un profondo “pozzo” approssimativamente quadrato, di 1,5 metri per 1,5 metri, in cui venivano adagiati gli infanti che avevano potuto beneficiare del répit e che erano stati battezzati nell’adiacente fonte.
Insieme ai resti sono state trovate alcune monete - un “doppio” di Enrico VI e un “gettone” di Luigi XIV - retaggio di antiche superstizioni, si dice. Fin dall’antica Grecia ma anche in Palestina l’uso di accompagnare i morti con monete è assai diffuso. Richiama alla memoria il “caron dimonio” dantesco e l’obolo che le anime gli versano, secondo il sommo poeta, per farsi traghettare al di là del fiume Stige.

È un’ulteriore prova e dimostrazione che gli infanti sepolti nel “pozzo”, con il répit, erano stati liberati dalla condanna al limbo e potevano quindi entrare nell’aldilà. Il “limbus puerorum” nella Divina Commedia si trova infatti appena oltre l’ingresso all’Inferno e ben prima della riva del fiume. Che necessità avrebbero avuto, dunque, quelle anime di portare con sé l’obolo, se non potevano andare oltre il temuto limbo?
Con il passare del tempo, la pratica si sarebbe stemperata, riducendosi ad una semplice sepoltura - senza riti e senza preghiere, se non una veloce benedizione - in quelle buie fosse, forse con la speranza che i fanciulli già passati oltre avrebbero portato con sé anche le anime dei nuovi corpicini messi a giacere di fianco a loro.
Ma di questo non abbiamo alcuna traccia documentale. Le minacce e le scomuniche della Chiesa richiedevano assoluto silenzio e discrezione.
Un caso interessante e misconosciuto è quello di Luzzogno in Valstrona (Piemonte Settentrionale) dove è ancora ottimamente conservato l’ossario dei bambini mai-nati, all’esterno della parrocchiale, proprio accanto alla cappella-battistero (l’attuale battistero si trova all’interno della chiesa). La tradizione locale conserva ancora il ricordo di ciò che vi accadeva, ultima rimanenza del répit, che in paese senza dubbio si era celebrato, in precedenza, al santuario della Colletta.
Costruita a partire dal 1711, la “fossa dei bambini” sorge sul lato settentrionale della chiesa parrocchiale e per la precisione a nord-ovest, la direzione dell'oltretomba già secondo gli aruspici Etruschi e poi Romani e condivide il tetto di copertura con la cappella adiacente, più piccola, non un vero e proprio battistero, ma un ambiente che ne simula in qualche modo lo scopo.
Una botola (oggi murata) nel pavimento dell'ossario permetteva di calare i corpicini fino a deporli sullo scivolo che li avrebbe portati nella loro dimora eterna, un vano spostato sotto la cappella piccola e forse un poco oltre.
I teschi con tibie incrociate e nastro colorato ad avvolgerli, ai lati della cancellata dell'ossario, annunciano la nascita e insieme la morte dei piccoli. L'elaborato motivo della cancellata stessa mostra la vita nel suo continuo divenire, con filari e foglie che si avvolgono e svolgono nell'infinito perpetuarsi dell'esistenza. L'efficace dipinto al di sopra è un monito e insieme un atto di fede e di speranza grandiosa. L'episodio crudamente rappresentato è tratto dalla Bibbia e precisamente dal Libro di Ezechiele.
L'infante, calato all'interno dell'Ossario, avrebbe certamente meritato la misericordia divina. Al termine dello scivolo, consegnato al riposo eterno, avrebbe avuto sopra di lui il cielo della “nuova terra”. Gli angeli, i tre sopra l'ingresso della cappella piccola, con le tuniche dei colori della terra, del cielo e della vita in mezzo a loro, avrebbero preso le piccole anime risollevandole dalla polvere e le avrebbero portate in paradiso.
BIBLIOGRAFIA
Jacques Gélis , De la mort à la vie: Les « sanctuaires à répit », in Ethnologie française nouvelle serie, T. 11, No. 3, Cultes officiels et pratiques populaires (juillet-septembre 1981), pp. 211-224, Presses Universitaires de France, Paris, 1981
F. Casalini e F. Teruggi, Mai Vivi Mai Morti, Giuliano Ladolfi Editore, Borgomanero, 2015
I massi coppellati del ritorno alla vita
Le risposte, affermative o meno, a certe intuizioni, arrivano spesso inaspettate, proprio quando non le si cerca. Altre volte, invece, si manifestano perché ardentemente volute e cercate.
La commenda giovannita di L’Argentière-La-Bessée, nell’Alta Provenza francese, è un sito di notevole interesse storico e culturale, ma anche una vera “capsula del tempo” in cui sono rimaste cristallizzate usanze antiche, mirabilmente conservate insieme alle sovrapposizioni dei secoli successivi.

Esiste un progetto di recupero della piccola area, elaborato all’indomani delle campagne di scavo effettuate fra il 1996 e il 2005, ma la burocrazia, gli interessi e la scarsa attenzione, mascherati da croniche e provvidenziali “mancanze di fondi”, non ne hanno ancora - e chissà per quanto - consentita la realizzazione. Così le piccole grandi meraviglie di questo luogo misterioso languono, nell’attesa di tornare alla luce.
La visita degli interni della cappella-oratorio di Saint Jean è tutt’ora interdetta per motivi di sicurezza. Ma la curiosità e la perseveranza, unite ad un rocambolesco giro di telefonate, email e messaggi, ci ha infine schiuso quelle porte, rimaste a lungo chiuse.
L’oratorio in pietra dai riflessi dorati sorge su uno sperone roccioso che, secoli addietro, dominava la Durance, che vi scorreva sotto. Oggi l’alveo del fiume scorre molto più distante.

La commenda risale almeno al 1208 e la nuova chiesa fu costruita dove già sorgeva un qualche altro edificio, forse una piccola cappella, le cui prime tracce risalirebbero al X-XI secolo.
Sulla parte alta della roccia e sul versante verso il fiume, con evidenti risvolti simbolici che richiamano la sacralità della Durance e delle sue acque, furono ricavate diverse tombe rupestri, più volte riutilizzate in epoche diverse.
In prossimità di due di queste sono ancora visibili piccole coppelle, interpretate come “segnali” della presenza di una tomba senza, tuttavia, che si possa stabilire se le fosse siano state ricavate vicino alle coppelle oppure il contrario.

La presenza di sepolture di fanciulli, almeno 28, inseriti nelle fosse già esistenti o deposti nella nuda terra in prossimità del muro della cappella oppure ai piedi della roccia, inoltre, ha destato non poco stupore, facendo concludere che il luogo possa essere stato un santuario del “ritorno effimero alla vita” o répit.
La struttura più interessante è però la roccia stessa, in cui è stata intagliata, da tempo immemore, una scala che pare fermarsi in prossimità del muro esterno dell’abside. La gradinata è all’origine del curioso toponimo “Gradis Karuli” o “De Gradibus Karoli”, di ignota origine e che richiama non certo Carlo Magno, come si cerca di sostenere, quanto una divinità ancestrale locale, Carrus, personificazione della montagna e quindi della roccia stessa.
È stata interpretata dagli archeologi come un “percorso”, la rimanenza di una via pellegrina che, scavalcando lo sperone, si inoltrava poi nella cittadella fortificata. Anche il rinvenimento di una pavimentazione in ciottoli, che occupa quasi tutta l’area dell’edificio, sembra corroborare l’ipotesi e giustificare in tal modo la scelta del luogo per edificarvi la cappella.
Ma le risultanze degli scavi e la possibilità di vedere con i nostri occhi l’interno dell’edificio, hanno svelato molti altri dettagli, registrati e opportunamente non spiegati, che raccontano una storia ben diversa.

La “scala”, infatti, prosegue al di sotto dell’abside, fermandosi in corrispondenza del punto in cui fu innalzato l’altare. L’edificazione non mirò a distruggere la “scala”, bensì a inglobarne con molta attenzione la parte terminale. Si chiarisce così la necessità di far intervenire le “maestranze lombarde”, la fraternità italiana dei “costruttori di cattedrali”, i Comacini, che provvidero all’opera, altrimenti non particolarmente difficoltosa. Nessun altro, all’infuori di quegli abili architetti, scultori, scalpellini, carpentieri, muratori, sarebbe stato in grado di realizzare una tanto mirabile sovrapposizione.
Grazie al loro intervento e alla scelta di riempire lo spazio absidale fino al nuovo piano di calpestio con strati di materiali diversi appositamente collocati, tutto si è perfettamente conservato. La “scala” procede con andamento leggermente curvo ed è composta di undici gradini, più uno spazio sommitale, per un totale di 12 piani sovrapposti, quantità che ha un valore simbolico, astroenergetico e numerologico non trascurabile e certamente voluto.
Appoggiandosi parzialmente al piano sommitale, i costruttori realizzarono una piattaforma rettangolare rialzata, ottenuta giustapponendo frammenti di un elegante sarcofago di chiara origine gallo-romana, su cui elevare l’altare. Ciò testimonia una frequentazione molto antica del luogo e la sua evidente sacralità.
È però la parte dello spazio sommitale in cui culmina la “scala”, leggermente decentrata rispetto alla chiesa (al centro c’é infatti l’altare), a riservare la sorpresa più grande. Qui infatti è stata ricavata una coppella di discrete dimensioni e profondità, rimaneggiata successivamente fino ad assumere una forma grossolanamente e approssimativamente rettangolare. Essa è ben più antica e diversa da quella, recente e ben squadrata, rinvenuta all’esterno della chiesa e che fu utilizzata per innalzare una croce rituale in legno, a contrassegnare il cimitero.

I pochi studi e i quaderni di scavo si limitano, di nuovo, a registrarne la presenza evitando di indagarne lo scopo. C’é tuttavia un piccolo dettaglio che indica come proprio questo fosse il punto più importante e quello cui era rivolta ogni devozione.
In cima alla parte visibile della “scala”, sul muro esterno dell’abside, sono state infatti incise, chissà quanto tempo fa e da chissà quali mani, tre croci. Due sono più incerte e frettolose, ma la terza, quella più grande e più profonda, forse la più antica, è posizionata proprio nella direzione della coppella nascosta, anziché dell’altare, come ci si potrebbe aspettare.
Evidentemente qualcuno, dopo la costruzione dell’oratorio, ancora conosceva precisamente l’esistenza e la collocazione della coppella, che segna il punto più forte della roccia e ha voluto segnalarla, affinché non fosse dimenticata.
I “gradini di Karolus/Carrus” non erano quindi “una strada”, bensì un “percorso rituale”, verso la cima della roccia e l’intero sperone era un grande altare, una “pietra santa” - da cui il nome di uno dei due ospitali del luogo - presso cui celebrare l’ “eterno ritorno”, la buona morte, grazie alla quale essere proiettati in una nuova vita.

La rugiada e la pioggia che si raccoglievano nella coppella, diventando acqua lustrale, erano il mezzo consacrato grazie al quale essere “liberati” dalle catene del destino mortale, sia per gli adulti che, a maggior ragione, per i bambini mai-nati. L’uso dell’acqua quale mezzo per far emettere il “soffio” vitale a quegli sventurati fanciulli è ben documentato, ad esempio a Saint Martin de Belleville, in Savoia, dove venivano immersi in una vasca. La presenza delle tombe di tre infanti - le più antiche - proprio in fondo alla “scala”, conferma che il répit si svolgesse qui anziché all’interno della chiesa. Se la loro scarsa quantità è dovuta all’efficacia del culto, si spiegano anche le altre 25 sepolture, più recenti e molto più numerose in una collocazione diversa: il rito forse non funzionava più perché la coppella non era più accessibile. Perciò, come accadde in moltissimi altri santuari del “ritorno effimero alla vita” l’ultima speranza, seppellendoli “sotto gronda”, veniva riposta nell’acqua piovana che, sacralizzata dal contatto con il tetto del luogo sacro, avrebbe forse potuto, in qualche modo, salvarli.
Così, inaspettatamente, si è sollevato un velo disteso dalla storia e dagli uomini, svelando fugacemente uno degli scopi per cui su certi massi venivano incise coppelle.
BIBLIOGRAFIA
Emile Thevenot, Divinités et Sanctuaires de la Gaulle, Fayard, Paris, 1968
P. Guillaume (abbé), Notice historique sur l’Argentière, in Bulletin de la Société d’études des Hautes-Alpes, 1883
J. Roman, Monographie du mandement de l’Argentière, Paris, Picard, 1883
S. Tzortzis e I. Séguy, Pratiques funéraires en lien avec les décès des nouveau nés. À propos d'un cas dauphinois durant l'Époque moderne: la chapelle Saint-Jean à l'Argentière-la-Bessée (Hautes-Alpes), in Socio-anthropologie, n° 22, 2008
G. Giordanengo, L'Église de L'Argentière, in Congrès archéologique de France, 130e session, 1972, Dauphiné, Paris, 1974
F. Casalini e F. Teruggi, Mai Vivi Mai Morti, Giuliano Ladolfi Editore, Borgomanero, 2015
Il mistero di Theopoli, la città perduta delle alpi provenzali
Sul versante alpino francese sud-occidentale, bagnato dalle placide acque della Durance, c’è ancora un enigma che resiste al tempo e agli uomini. In una stretta valle, una “pietra scritta” di epoca gallo-romana, incisa in un enorme masso che domina il corso tortuoso del torrente Riou, è l’unica testimonianza certa dell’esistenza di un “locus” leggendario chiamato Theopoli, scomparso dalla memoria e mai più ritrovato.
Il testo celebra l’impresa del prefetto gallo-romano Claudius Postumus Dardanus, che, fra il IV e il V sec., fece aprire, tagliandola nella viva roccia, la nuova e più agevole strada per raggiungere l’odierna piana di Saint Geniez, prima accessibile soltanto risalendo il difficile e assai più lungo percorso attraverso la valle di Vançon. Composta in parole semplici, l’iscrizione non ha ancora svelato tutti i suoi segreti, primo fra tutti l’assenza di riferimenti cronologici, inusuale soprattutto in epoca romana. Diciassette foglie di edera, pianta sacra a Dioniso come la vite, intervallano la scrittura e la valenza anche funeraria di questo rampicante potrebbe suggerire che sia stata incisa dopo la morte del potente condottiero, in suo onore e memoria.
Nascondono, come un codice, in bella vista un messaggio comprensibile solo ai meritevoli.
Dardanus è un personaggio storico conosciuto e misterioso insieme. Prefetto di tutte le Gallie, immenso territorio che comprendeva anche la Spagna e la Bretagna, era stato inviato in Provenza dall’Africa per contrastare la calata dei Vandali e poi dei Visigoti.

Di origini modeste - aveva cominciato la propria carriera come “advocatus” - portava il nome del mitico tiranno di Troia, figlio di Zeus e della regione di Dardania, raramente in uso e soltanto in Africa e in area ellenica. Nella “pietra scritta” viene poi celebrato come “vir inlustris” e la moglie Nevia Galla, nella stessa iscrizione, come “clarissima et inlustre”, titoli che indicano l’appartenenza di entrambi all’aristocrazia senatoriale più potente della loro epoca.
Forse tra le due campagne prefetturali di cui fu investito (401/404 d.C. o 406/407 d.C e 412/413 d.C.), Dardanus, nonostante avesse eletto Arles a capitale dei propri domini, decise di riparare con 40.000 soldati e legionari sul remoto pianoro sorvegliato dal picco di Dromon, cinquecento metri più in alto della valle della Durance e qui, dopo aver costruito strade e mura turrite, si sarebbe insediato.
A questo punto comincia il mistero di Theopoli.
Si pensa che il condottiero avesse scelto quel luogo, così appartato, strategico (qui si “riunivano” molte strade di valico delle Alpi e di discesa verso il mare) e facilmente difendibile, in seguito alla conversione al Cristianesimo, che ben conosceva poiché era grande amico di Sant’Agostino e interlocutore privilegiato di San Girolamo, con i quali avrebbe intrattenuto per tutta la vita fitte relazioni anche epistolari: soltanto due preziose lettere si sono conservate, quella del 417 scritta dal santo di Ippona e quella del 414 del santo di Stridone, entrambe a lui indirizzate.
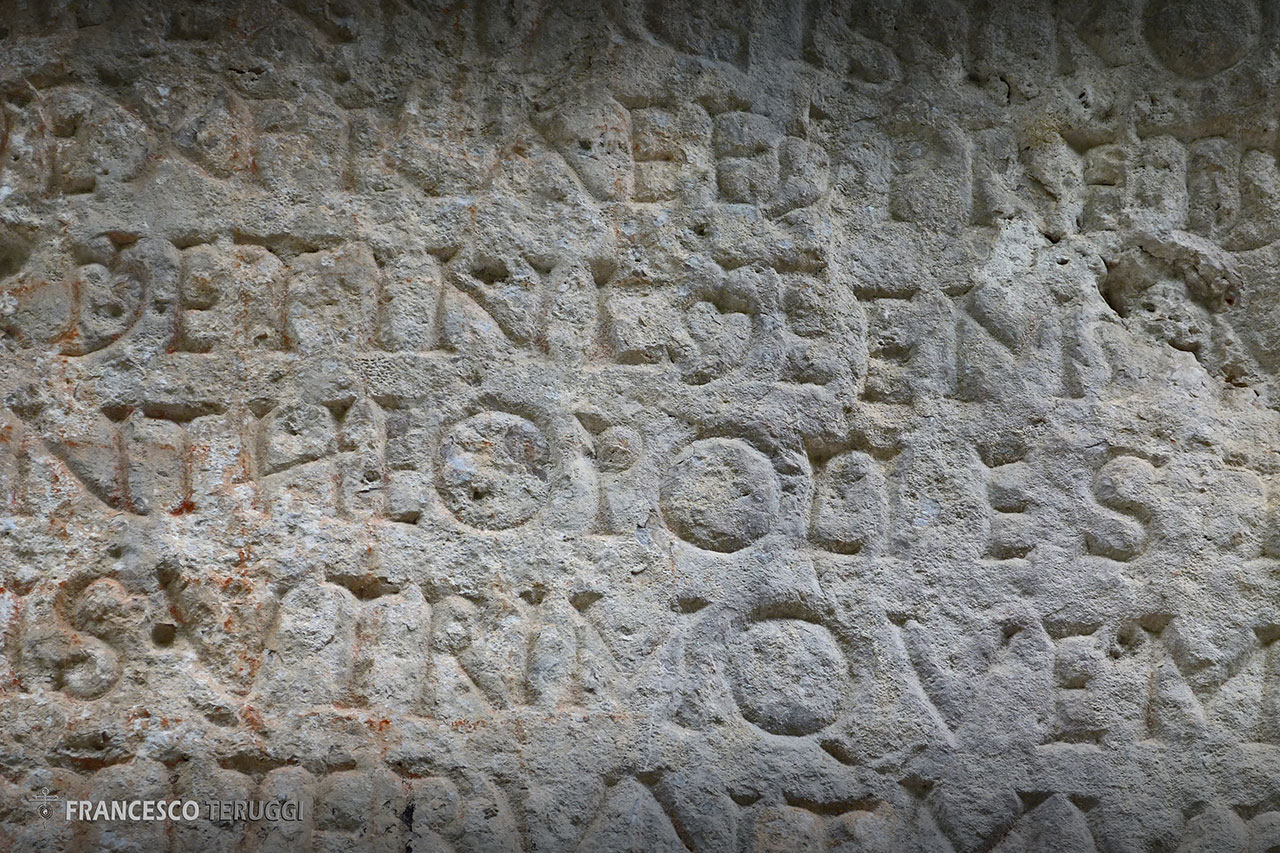
La sua magione potrebbe essere sorta non a Chardavon, alle porte del plateau (dove si sarebbero insediati almeno dal XI sec. alcuni monaci agostiniani) ma presso l’attuale Saint Geniez, piccolo paese che conta soltanto 98 abitanti. Saint Genièz-Genesus, mediorientale come l’illustre prefetto delle Gallie, era infatti uno dei martiri più venerati della Gallia meridionale tra il IV e il V secolo. I suoi resti erano sepolti proprio ad Arles e si ritiene che il condottiero possa averne portata una parte fin sul plateau di Dromon, per custodirle nella cappella costruita presso la sua dimora.
Il luogo prescelto si chiamava “Theopoli”, nome riscontrato storicamente soltanto una volta, con la “s” finale e almeno un secolo più tardi, in relazione ad Antiochia di Siria. Distrutta da terremoti e invasioni, come racconta lo storico Malalas, la città era stata ricostruita nel 528 da Giustiniano I con il nuovo nome di “città degli dei” su consiglio di San Simeone Taumaturgo, ma l’aveva conservato per poco tempo. Con l’arrivo degli arabi sarebbe stata ribattezzata Antakiya.

“Theopoli”, invece, non avendo la “s” terminale non può essere un nome riconducibile alla lingua greca e quindi neppure agli scritti di Sant’Agostino. Anzi, il termine “locus” presente nella “pietra scritta” e la perifrasi “locus cui nomen theopoli est” indicano senza dubbio un luogo di culto (la Basilica di Betlemme con la Grotta della Natività ad esempio era detta “locus Betlehem”), la tomba di un santo martire o il centro religioso di un “pagus” (villaggio rurale). “Theopoli” era quindi, come sostenuto da molti studiosi tra cui A. Grenier e W. Seston, più verosimilmente un luogo sacro custodito in armi anziché un’installazione militare.
Ma è certo, così si desume facilmente dalla “pietra scritta”, che il luogo esistesse già prima dell’arrivo di Dardanus il quale, portandovi le reliquie del santo Genesus, l’aveva riconsacrato al dio cristiano e l’aveva trasformato in una vera e propria città turrita con mura e strade di collegamento.
È possibile che il nome originario fosse quello del picco più alto che domina il plateau a nord-est: Theous, toponimo ancora oggi esistente ma di ignota origine, forse celtica e che potrebbe appartenere a una qualche divinità o un nume tutelare. Il prefetto delle Gallie ne avrebbe fatto un neologismo, unendolo al termine greco “polis” per indicare, con un gioco di parole, in Theous-poli(s) la città presso Theous e non la “città degli dei”.

Ma di Theopoli oggi non c’è più traccia, soltanto leggende. Una racconta di un enorme tesoro nascosto tra le montagne intorno al pianoro. Il più grande studioso di questo enigmatico luogo, Roger Correard, sostiene che il tesoro fosse il bottino dei Visigoti trafugato durante il sacco di Roma e poi affidato dai barbari a Dardanus, con il quale intrattenevano buoni rapporti. Che il tesoro sia stato sepolto insieme ad Alarico nella tomba ricavata deviando un corso d’acqua vicino a Cosenza è infatti leggenda, così come è improbabile che possa aver raggiunto Rennes-le-Chateau dove lo cercavano i nazisti.
Fu proprio grazie al prefetto Dardanus che il re visigoto Atatulfo, appena succeduto al cognato Alarico, giunto con le sue truppe in Gallia accettò la sottomissione all’imperatore Onofrio, anziché all’usurpatore Giovino. Mentre la rivolta veniva sedata, i Visigoti furono arruolati per combattere i Vandali e gli Alani che stavano invadendo la Spagna e forse fu in quest’occasione che il tesoro venne affidato a Dardanus e nascosto a Theopoli. Ma Ataulfo morì in battaglia, i Visigoti non tornarono in Provenza e il tesoro non fu mai riscattato.
Intanto, alleati dell’imperatore fantoccio Giovino erano i Burgundi, tribù di origini visigote il cui re Gundicaro stabilì di accompagnare l’usurpatore fino alla Gallia del Sud (Provenza) dove si auto-nominò re delle Gallie. Avendo a loro volta accettato la sottomissione al legittimo reggente Onorio, avrebbero ricevuto, come terra in cui insediarsi, la Savoia.

Gundicaro, Gundikar fu il primo re burgundo a fregiarsi del titolo di Nibelungo. È infatti il Gunther della saga dei Nibelunghi, che risale proprio al IV-V secolo ma non sia sa dove ne come sia stata composta. Può essere il tesoro custodito da Dardanus quello favoloso di cui Gunther, nella saga era entrato in possesso dopo aver ucciso Sigfrido?
Certo è che Theopoli non era stata inizialmente scelta per custodire il tesoro, bensì per altri scopi misteriosi e ormai dimenticati. Se qualche traccia rimane forse può essere rinvenuta nel luogo sacro che ancora esiste ai margini del pianoro, proprio sotto il picco.
La cappella di Notre Dame du Dromon è un semplice oratorio seicentesco con grezzi muri di pietra e malta bruna. La struttura non colpisce l’occhio, ma da sempre il luogo è profondamente venerato, come testimoniano le numerose lastre graffite inserite nella muratura esterna, ex voto dei fedeli che furono benedetti dall’intercessione della Vergine.

I veri tesori sono all’interno. Nell’annesso settentrionale sono ancora visibili i resti di un pozzo cerimoniale lastricato, che richiama quello ben più famoso di Chartres. Si racconta che i lavori di sterro per ripristinarlo si siano interrotti dopo che la terra, in quel punto, presa a picconate, si era messa a tremare.
L’interno essenziale della chiesa, a navata unica con abside, mostra ancora le tracce di un’intonacatura artigianale. La cappella annessa sul lato meridionale è spoglia e l’altare ligneo è ormai in rovina, ma la roccia su cui è costruito il luogo affiora in più punti fino a un metro di altezza come se non ci fosse differenza fra la terra e l’edificio costruito dall’uomo. Alcune linee parallele graffite potrebbero essere atti di venerazione prodotti in epoche remote.
Presso l’abside maggiore, c’è l’immancabile sorvegliante, un viso di stucco quasi nascosto in un angolo che ha i lineamenti insoliti di una divinità con il berretto frigio, forse Mitra o Ganimede. Osserva l’altare, con la sua pietra consacrata, che non ha le consuete cinque croci (al centro e sui quattro angoli), bensì X inserite in cerchi e ruotate in modo da indicare i punti equinoziali e solstiziali, chiaro segno di un intento di natura astronomica e astrologica.
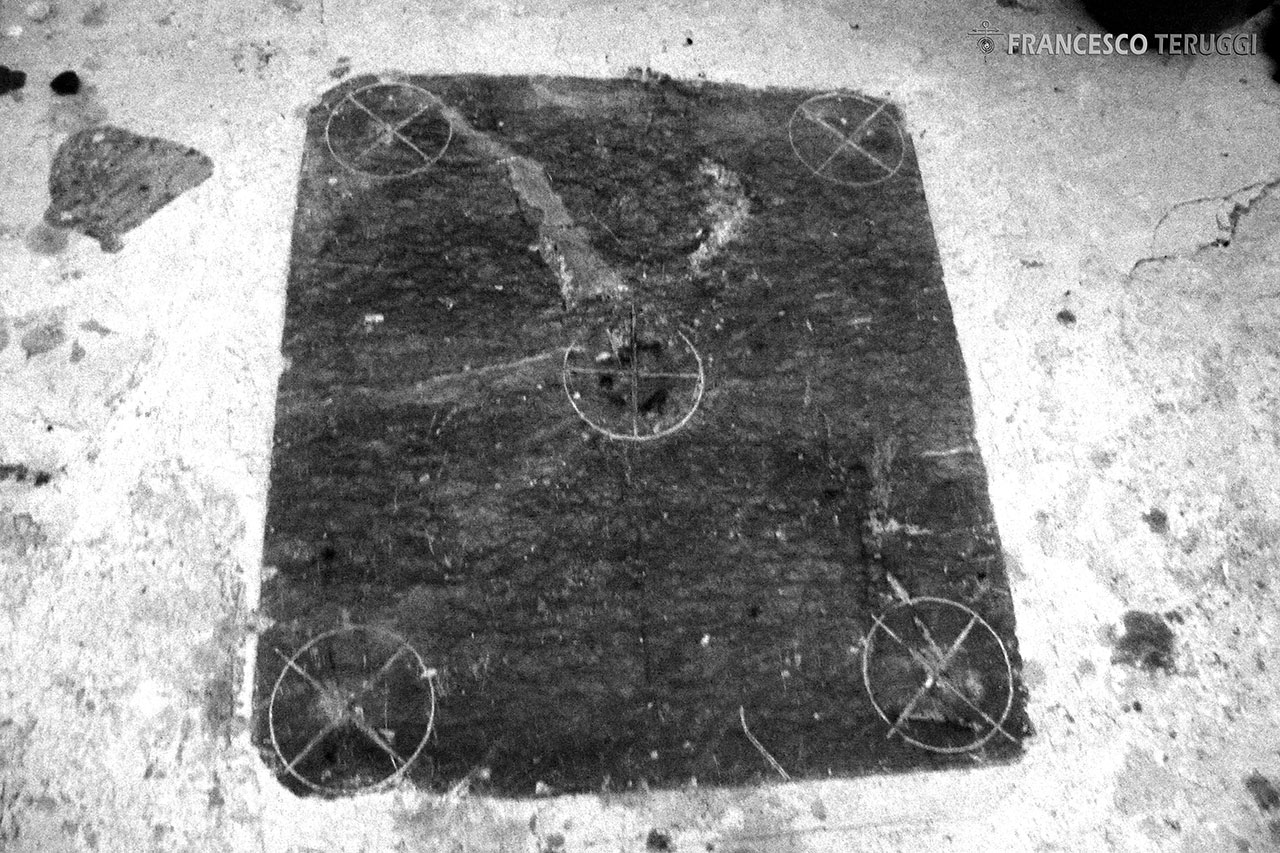
Ma la sorpresa più grande si trova in fondo alla scala intagliata nella roccia che scende sotto la pavimentazione. Qui, fuori asse rispetto alla cappella superiore, si apre infatti un’eccezionale cripta, nota già dal X secolo ma riempita di detriti e riscoperta soltanto nel XVII secolo, unica nel suo genere.
Non c’è un altare; al suo posto erompe invece una grande roccia sporgente, come un ventre gravido, quello della dea-terra, della Grande Madre.
La luce del sole entra ad illuminarla soltanto nei giorni del solstizio estivo, all’alba, attraverso la finestrella sul lato opposto, accuratamente orientata. Nello stesso istante l’altra finestra, laterale, inquadra perfettamente il “polo celeste”, l’Orsa Minore, con la Stella Polare.
Tre colonne romaniche reggono la volta stretta e due capitelli sono scolpiti con motivi enigmatici. Uno presenta sui quattro lati volute che si attorcigliano come fossero nodi, l’altro mostra genitali e teste di toro, spighe di grano e due pavoni.
È un luogo antico, da sempre frequentato con devozione, che è passato attraverso le dominazioni, le religioni, gli editti e le distruzioni, conservandosi miracolosamente intatto.

Quando si scende, ci si sente come spaesati, quasi che il tempo perda significato e ci si trovi in un “altrove” che non appartiene a questo mondo. La roccia attrae ogni attenzione, come una divinità assisa sul trono. La chiamano “Pietra della fertilità”, ma è un nome che non rende merito, onore e giustizia a ciò che dimora nel silenzio di quella cripta.
La presenza, nella cappella superiore, della testina identificata con Mitra o Ganimede, per quanto molto posteriore, sembra suggerire che l’ipogeo fosse un luogo di “incubazione”, pratica non soltanto greca, mediorientale e sarda ma anche celtica che, mediante il “sonno” accanto al simulacro della divinità ancestrale, permetteva di riceverne guarigione e messaggi. L’antica grotta potrebbe dunque essere un santuario druidico diventato poi un antro mitraico dove i numerosi legionari del contingente potevano praticare il loro culto.
La cripta di Dromon ha resistito ai millenni. Nonostante l’editto di Teodosio (380 d.C.) e i successivi decreti, che vietavano qualunque forma di culto e perfino l’accesso ai templi pagani, è rimasta gelosamente custodita dai picchi che sovrastano il plateau. Ha attratto fondazioni monastiche e una chiesa è stata eretta su di essa affinché il culto di questo luogo potesse continuare. Tra i suoi muri e ai piedi della roccia sacra ancora dorme il suo sonno il mistero di Dardanus e di Theopoli.

BIBLIOGRAFIA
Roger Correard, Théopolis. Gite Secret Du Lion, Arqa, 200
Aa. Vv., Bulletin de la Société d'études des Hautes-Alpes, Société d'études des Hautes-Alpes, Gap, 1943
Cavalieri di San Giovanni. Una storia millenaria tra Gerusalemme e l'Ossola
Scritto da Francesco Teruggi
La storia dei Cavalieri di San Giovanni, la loro diffusione in occidente e
la loro penetrazione fin nel cuore dell'Ossola:
la prima pubblicazione storica ufficiale
del S.O.G.IT sezione di Verbania.
A cura di Francesco Teruggi
Anno di edizione: 2018
Pubblicato da Sogit-Verbania
Pagine: 32
Pubblicato da S.O.G.IT. - Soccorso dell'Ordine di San Giovanni in Italia, sezione di Verbania
Disponibile presso Sogit Verbania
e in formato elettronico su http://www.sogitverbania.it
Recensione di Rosamaria Cerone su GoodReads
Come chiunque voglia comunicare con gli altri, anche l'autore parte da ciò che gli è più vicino: un mistero ha percepito attorno a sé, in quel 'remoto paese dell'Ossola', a Ornavasso, all'interno del Santuario della Beata Vergine della Guardia.
Dopo lunghi studi, notti insonni e l'ennesima visita al Santuario, egli comprende cosa è mancato sino ad allora: uno sguardo nuovo, una nuova prospettiva, inversa ed ugualmente corrispondente alla realtà. Così, ha la certezza che una nuova lettura dei dipinti all'interno del Santuario può essere intrapresa.
L'autore scopre indizi e indicazioni a senso doppio o multiplo e grazie ai suoi precedenti studi riesce a individuare una 'via di conoscenza'. Di cosa?
Ci sono indizi nei colori, nei numeri, nell'architettura del Santuario, indizi ovunque, in un 'gigantesco e meraviglioso libro di pietra', da leggere con l''occhio dell'alchimista'. E con questo sguardo nuovo, tutto prende nuovo significato. A volte si ha la sensazione che il troppo conoscere porti a nuova conoscenza, come nel caso dei 'tre Giuseppe'...ma non spiego, dovrete leggere il libro. Leggere prima e visitare il Santuario dopo e se seguirete l'autore, vi metterete a misurare trabucchi e gettate, perchè così facendo egli ha messo in luce che la Guardia è luogo di 'trasmutazione', in architetti in questo caso. Purtroppo io coi numeri mai andata troppo d'accordo, così mi sono persa nella descrizione del Santuario, anche se la similitudine con la forma del 'carapace' mi ha gettata a piè pari nella 'Città Proibita', dove molte tartarughe di pietra fanno mostra e significato di sé.
Seguendo Giuseppe d'Arimatea, detentore del Graal, si rintraccia il potere femminino misconosciuto perchè rifiutato in certe epoche, tanto da sovrapporvi strati e strati di inutili preconcetti. E quasi a presagire l'avvento della Dea, come da titolo, c'è la fiduciosa tenerezza che l'autore ha per la sua metà femminile e non solo quella interiore. Tralascio di menzionare gli altri strumenti pratici e culturali che egli ha usato per studiare il mistero, come la rabdomanzia e la radioestesia, per la mia assoluta ignoranza in materia, però è bravo l'autore ad un certo punto, come in un giallo, perchè guardando la foto di un medaglione di marmo sotto l'altare della B.V., dalle venature rosate su fondo bianco, vedo il collegamento: la forma di un utero, rappresentazione e senso della Donna, della Dea. Eccoci.
Purtroppo, da qui in poi ricominciano misurazioni e domande e si rompe il clima magico introdotto dalla 'presenza' della Dea. Con leggera noia ricomincio a chiedermi: chi è il misterioso storico locale che l'autore consulta e rende spettatore delle proprie elucubrazioni alla fine del libro, fine ancor lontana, rilevo. Chi è il misterioso abate? Dove va quel famoso 'alchimista e medico milanese' dopo la Santa Inquisizione? Ecco che la storia del luogo diventa importantissima, i suoi abitanti, l'anima della stessa gente di Ornavasso. E l'idea che quella concepita attraverso lo Spirito Santo sia stata anche la Beata Vergine, per una 'quasi' di tutto come me, è assolutamente affascinante!
Si fa difficile però seguire la storia della struttura e di quelle vicine, difficile capire il legame che le unisce e il perchè siano state costruite a Ornavasso, a parte linee energetiche e corsi d'acqua sotterranei. La seconda parte del libro è dedicato alla Dea, ma per ben 4 capitoli ancora nulla! siamo sempre alla ricerca di un Suo 'segno'!
Segno trovato tra le 'mamme' e un mascherone di pietra su una torre, simboli della rinascita solare in chiave ermetica. Così il dipinto della Guardia, della B.V. che allatta, non è altro che l'immagine cristianizzata della Dea, labile traccia di un culto iniziatico : ecco cosa comprese l'abate. Ornavasso, il suo poggio, i suoi antichi boschi, furono 'tempio delle origini' ai tempi dei Leoponti: questa la conclusione dell'autore, ma...che significato ha il blasone di Ornavasso sul palazzo municipale? Che dire del significato del nome stesso del paese? E delle stranezze del fregio sopra una cornice del Santuario?
Proprio quando il mistero sembrava essere stato svelato, ancora domande, sempre domande, ancora studio, sempre studio! Perchè questa è la vita del curioso e dello studioso: cercare risposte. A volte, creare domande.
Altro...
I segreti di Ornavasso, un paese magico
Puoi leggere l'articolo originale su KARMANEWS
di Francesco Teruggi. Un luogo denso di spiritualità e di energia, con alcuni segreti forse mai svelati: un santuario ottogonale, una Madonna a seno nudo, il Graal
Tutti conosciamo le magnifiche piramidi d'Egitto, i circoli di pietre inglesi, le città misteriose dell'Anatolia e le grandi cattedrali di Francia, ma può capitare di scoprire che luoghi altrettanto densi di spiritualità e di energia si trovino proprio fuori dall'uscio di casa nostra.
C'è un paese, ai piedi delle montagne occidentali dell'antico Ducato di Milano, proprio all'imbocco dell'Ossola, che fu teatro di una storia misteriosa e sconosciuta, la vicenda incredibile di un grandioso Santuario come mai se ne erano visti in quelle valli, costruito nel XVII secolo intorno all’immagine sconveniente, eretica e prodigiosa, di una Madonna che allatta a seno scoperto, come un'antica dea celtica.

Svizzera. La valle del Goms (alto Vallese)
Discendenti Sassoni
Ornavasso era la propaggine meridionale del piccolo mondo dei Walser (contrazione del tedesco Walliser, cioè vallesano), genti robuste - forse gli ultimi discendenti dei Sassoni che nel VIII secolo erano migrati verso l'Europa centro-meridionale - stanziate nel cuore delle Alpi Svizzere, tra il Gottardo e l'Oberland Bernese, spinte a colonizzare forzatamente gli alpeggi alle quote più alte e inospitali delle montagne intorno al Monterosa, laddove si credeva che riuscissero a sopravvivere solo demoni e animali mostruosi.
Così, agli albori dell'anno Mille, proprio quando sembrava avvicinarsi la temuta Fine del Mondo annunciata dall'Apocalisse, mentre fiorivano racconti popolari e il millenarismo dilagava tra superstizioni profezie e dottrine escatologiche, quelle povere famiglie, con le loro tradizioni forse alto-alemanniche, erano giunte nella Valle del Goms (foto sopra), percorrendo i passi lasciati liberi dalle nevi che li avevano ricoperti nei secoli precedenti. Poi si erano diffuse verso sud-est tra il XIII e il XV secolo, quando piccoli gruppi avevano cominciato a staccarsi dalle colonie madri alla ricerca di nuovi pascoli e nuove terre coltivabili.
Le leggende sul "piccolo popolo"

La casa dei folletti.
Alla fine del Quattrocento si contavano ben quaranta insediamenti walser sparsi tutto intorno al Monte Rosa. Una di queste era, appunto Ornavasso, dove i Walser avevano portato tutta la loro ricchezza culturale, tramandata oralmente nelle sere d'inverno intorno al fuoco nella stube: piccoli e grandi misteri, animali mitologici; ombre e rumori e soprattutto le leggende sul “piccolo popolo”, i Twerg, Tegi, Zwergi che vivono nelle montagne; i wilde Männlein, i selvaggi abitanti dei boschi; i Nachtvolk, il popolo della notte; il terribile Basilisco che striscia tra le erbe alte e si nasconde negli anfratti; spiriti e fiammelle che si manifestano nella notte; orde di streghe che si riuniscono nelle valli più appartate; la processione dei morti - comune anche a molte località di pianura - che giungeva dalle cime innevate ad accogliere i nuovi morti per accompagnarli nell'oltretomba tra litanie e stridore di catene, quando passava negli alpeggi; il mito della Verlorene Thal, la “valle perduta” del Lys, in cui si racconta sorgesse la leggendaria colonia di Félik, inghiottita per punizione dalle nevi con tutte le sue ricchezze dopo che i suoi abitanti avevano rifiutato di accogliere e rifocillare un vecchio barbuto e cencioso, sotto le cui mentite spoglie si celava l'Ebreo Errante.
Una casa e un santuario ottagonale

Ornavasso, vista dall'alto.
È in questo magico paese che, nel 1659, si ritira un figlio cadetto della nobile e potente famiglia milanese dei Visconti di Modrone. In soli cinque anni, fa erigere sui terreni acquistati sopra l'abitato la sua dimora privata, un curioso edificio di forma ottagonale, dove immediatamente si insedia. Sarà l'inizio di una vicenda incredibile e misteriosa.
Negli anni seguenti, a una manciata di metri dai suoi possedimenti, una semplice cappella mariana spersa tra le balze boscose diventerà il fulcro e l'altare maggiore di un immenso santuario, anch'esso di forma ottagonale, la cui cupola raggiunge i 27 metri di altezza e si regge soltanto su otto grandi colonne di pietra. Opera poco nota di uno dei massimi architetti milanesi del tempo, Attilio Arrigoni, allievo del celeberrimo Francesco Maria Richini, è un capolavoro del più austero Barocco alpino, un monumento di inattesa perfezione.

Il Santuario di Ornavasso, a forma ottagonale.
In esso sembrarono realizzarsi, con la massima precisione, i principi della più rigida Controriforma, gli stessi emersi dal Concilio di Trento e ampiamente trattati da San Carlo Borromeo. Invece fu segretamente concepito, realizzato e costruito come una vera e propria cattedrale d'altri tempi, al pari di Chartres, Stephansdom a Vienna o Notre Dame a Parigi, grazie all'intervento silenzioso e quasi invisibile di esperti magistri, costruttori di cattedrali e alla volontà di quell'enigmatico cavaliere-abate.
Il complesso avrebbe dovuto comprendere tre diversi edifici: il grande santuario e, a non molta distanza, due ottagoni più piccoli concepiti come un immane volano capace di risvegliare e convogliare le immani energie celate nel sottosuolo.
Simboli nascosti di una sapienza antica
Le proporzioni dell'edificio più grande, mai terminato e mai veramente consacrato, manifestano la presenza in ogni particolare del numero aureo. Il suo impianto suggerisce la volontà di realizzare un'enorme rotonda che, però, non fu mai portata a termine.

La statua della Maddalena un tempo reggeva il Graal.
La sua posizione e le sue direzioni, apparentemente casuali, nascondono inaspettati, coerenti e potenti allineamenti con i fenomeni astronomici, astrologici e tellurici locali. Sotto di esso, nelle viscere della terra, dormono immani correnti energetiche capaci di prodigi, guarigioni impossibili e perfino di permettere il ritorno in vita dei bambini che nascevano già morti.
Altrettanto nei dipinti, nelle cornici affrescate, nelle tarsie, negli stucchi, così perfettamente aderenti ai dogmi, alla tradizione e all'ortodossia, occhieggiano i simboli nascosti e i glifi occulti di una sapienza antica e potente, di quel Graal che una statua sull'altare un tempo reggeva nella destra.
La morte dell'abate, i giochi di potere e uno sfortunato cedimento strutturale impedirono all'edificio di giungere alla sua forma definitiva. I successori del nobiluomo, cercarono comunque di portare a termine il progetto: la terza costruzione, sempre basata sulla stessa geometria a otto lati, vide presto la luce per desiderio della più potente confraternita del paese, ma intanto la prima, la dimora del prelato, lasciata all'incuria dei suoi eredi, veniva progressivamente abbandonata e smantellata.
Un progetto mai finito nella sua compiutezza

Oggi, al suo interno, la “Guardia” continua a custodire i preziosi indizi, nascosti e sfacciatamente in vista, di quella storia incredibile fatta di intrighi e di dominio, di sapienze ermetiche e di scienze perfette, di alchimia e di riti antichi, la vera epopea di un progetto impossibile: la storia leggendaria della Cattedrale dei Walser, l'immensa “macchina spirituale” capolavoro dell'ignoto abate-cavaliere-alchimista, che in esso aveva profuso tutta la propria conoscenza e i propri legami di sangue e di potere; un progetto immane, mai eguagliato neppure, più di un secolo dopo, dalla celebre Rennes Le Chateau.
Per saperne di più
La vera storia di Ornavasso è stata minuziosamente riscoperta e ricostruita dall'autore di questo servizio. Vedi: www.francescoteruggi.com
I segreti di Ornavasso, un paese magico
Puoi leggere l'articolo originale su KARMANEWS
di Francesco Teruggi. Un luogo denso di spiritualità e di energia, con alcuni segreti forse mai svelati: un santuario ottogonale, una Madonna a seno nudo, il Graal
Tutti conosciamo le magnifiche piramidi d'Egitto, i circoli di pietre inglesi, le città misteriose dell'Anatolia e le grandi cattedrali di Francia, ma può capitare di scoprire che luoghi altrettanto densi di spiritualità e di energia si trovino proprio fuori dall'uscio di casa nostra.
C'è un paese, ai piedi delle montagne occidentali dell'antico Ducato di Milano, proprio all'imbocco dell'Ossola, che fu teatro di una storia misteriosa e sconosciuta, la vicenda incredibile di un grandioso Santuario come mai se ne erano visti in quelle valli, costruito nel XVII secolo intorno all’immagine sconveniente, eretica e prodigiosa, di una Madonna che allatta a seno scoperto, come un'antica dea celtica.

Svizzera. La valle del Goms (alto Vallese)
Discendenti Sassoni
Ornavasso era la propaggine meridionale del piccolo mondo dei Walser (contrazione del tedesco Walliser, cioè vallesano), genti robuste - forse gli ultimi discendenti dei Sassoni che nel VIII secolo erano migrati verso l'Europa centro-meridionale - stanziate nel cuore delle Alpi Svizzere, tra il Gottardo e l'Oberland Bernese, spinte a colonizzare forzatamente gli alpeggi alle quote più alte e inospitali delle montagne intorno al Monterosa, laddove si credeva che riuscissero a sopravvivere solo demoni e animali mostruosi.
Così, agli albori dell'anno Mille, proprio quando sembrava avvicinarsi la temuta Fine del Mondo annunciata dall'Apocalisse, mentre fiorivano racconti popolari e il millenarismo dilagava tra superstizioni profezie e dottrine escatologiche, quelle povere famiglie, con le loro tradizioni forse alto-alemanniche, erano giunte nella Valle del Goms (foto sopra), percorrendo i passi lasciati liberi dalle nevi che li avevano ricoperti nei secoli precedenti. Poi si erano diffuse verso sud-est tra il XIII e il XV secolo, quando piccoli gruppi avevano cominciato a staccarsi dalle colonie madri alla ricerca di nuovi pascoli e nuove terre coltivabili.
Le leggende sul "piccolo popolo"

La casa dei folletti.
Alla fine del Quattrocento si contavano ben quaranta insediamenti walser sparsi tutto intorno al Monte Rosa. Una di queste era, appunto Ornavasso, dove i Walser avevano portato tutta la loro ricchezza culturale, tramandata oralmente nelle sere d'inverno intorno al fuoco nella stube: piccoli e grandi misteri, animali mitologici; ombre e rumori e soprattutto le leggende sul “piccolo popolo”, i Twerg, Tegi, Zwergi che vivono nelle montagne; i wilde Männlein, i selvaggi abitanti dei boschi; i Nachtvolk, il popolo della notte; il terribile Basilisco che striscia tra le erbe alte e si nasconde negli anfratti; spiriti e fiammelle che si manifestano nella notte; orde di streghe che si riuniscono nelle valli più appartate; la processione dei morti - comune anche a molte località di pianura - che giungeva dalle cime innevate ad accogliere i nuovi morti per accompagnarli nell'oltretomba tra litanie e stridore di catene, quando passava negli alpeggi; il mito della Verlorene Thal, la “valle perduta” del Lys, in cui si racconta sorgesse la leggendaria colonia di Félik, inghiottita per punizione dalle nevi con tutte le sue ricchezze dopo che i suoi abitanti avevano rifiutato di accogliere e rifocillare un vecchio barbuto e cencioso, sotto le cui mentite spoglie si celava l'Ebreo Errante.
Una casa e un santuario ottagonale

Ornavasso, vista dall'alto.
È in questo magico paese che, nel 1659, si ritira un figlio cadetto della nobile e potente famiglia milanese dei Visconti di Modrone. In soli cinque anni, fa erigere sui terreni acquistati sopra l'abitato la sua dimora privata, un curioso edificio di forma ottagonale, dove immediatamente si insedia. Sarà l'inizio di una vicenda incredibile e misteriosa.
Negli anni seguenti, a una manciata di metri dai suoi possedimenti, una semplice cappella mariana spersa tra le balze boscose diventerà il fulcro e l'altare maggiore di un immenso santuario, anch'esso di forma ottagonale, la cui cupola raggiunge i 27 metri di altezza e si regge soltanto su otto grandi colonne di pietra. Opera poco nota di uno dei massimi architetti milanesi del tempo, Attilio Arrigoni, allievo del celeberrimo Francesco Maria Richini, è un capolavoro del più austero Barocco alpino, un monumento di inattesa perfezione.

Il Santuario di Ornavasso, a forma ottagonale.
In esso sembrarono realizzarsi, con la massima precisione, i principi della più rigida Controriforma, gli stessi emersi dal Concilio di Trento e ampiamente trattati da San Carlo Borromeo. Invece fu segretamente concepito, realizzato e costruito come una vera e propria cattedrale d'altri tempi, al pari di Chartres, Stephansdom a Vienna o Notre Dame a Parigi, grazie all'intervento silenzioso e quasi invisibile di esperti magistri, costruttori di cattedrali e alla volontà di quell'enigmatico cavaliere-abate.
Il complesso avrebbe dovuto comprendere tre diversi edifici: il grande santuario e, a non molta distanza, due ottagoni più piccoli concepiti come un immane volano capace di risvegliare e convogliare le immani energie celate nel sottosuolo.
Simboli nascosti di una sapienza antica
Le proporzioni dell'edificio più grande, mai terminato e mai veramente consacrato, manifestano la presenza in ogni particolare del numero aureo. Il suo impianto suggerisce la volontà di realizzare un'enorme rotonda che, però, non fu mai portata a termine.

La statua della Maddalena un tempo reggeva il Graal.
La sua posizione e le sue direzioni, apparentemente casuali, nascondono inaspettati, coerenti e potenti allineamenti con i fenomeni astronomici, astrologici e tellurici locali. Sotto di esso, nelle viscere della terra, dormono immani correnti energetiche capaci di prodigi, guarigioni impossibili e perfino di permettere il ritorno in vita dei bambini che nascevano già morti.
Altrettanto nei dipinti, nelle cornici affrescate, nelle tarsie, negli stucchi, così perfettamente aderenti ai dogmi, alla tradizione e all'ortodossia, occhieggiano i simboli nascosti e i glifi occulti di una sapienza antica e potente, di quel Graal che una statua sull'altare un tempo reggeva nella destra.
La morte dell'abate, i giochi di potere e uno sfortunato cedimento strutturale impedirono all'edificio di giungere alla sua forma definitiva. I successori del nobiluomo, cercarono comunque di portare a termine il progetto: la terza costruzione, sempre basata sulla stessa geometria a otto lati, vide presto la luce per desiderio della più potente confraternita del paese, ma intanto la prima, la dimora del prelato, lasciata all'incuria dei suoi eredi, veniva progressivamente abbandonata e smantellata.
Un progetto mai finito nella sua compiutezza
 Oggi, al suo interno, la “Guardia” continua a custodire i preziosi indizi, nascosti e sfacciatamente in vista, di quella storia incredibile fatta di intrighi e di dominio, di sapienze ermetiche e di scienze perfette, di alchimia e di riti antichi, la vera epopea di un progetto impossibile: la storia leggendaria della Cattedrale dei Walser, l'immensa “macchina spirituale” capolavoro dell'ignoto abate-cavaliere-alchimista, che in esso aveva profuso tutta la propria conoscenza e i propri legami di sangue e di potere; un progetto immane, mai eguagliato neppure, più di un secolo dopo, dalla celebre Rennes Le Chateau.
Oggi, al suo interno, la “Guardia” continua a custodire i preziosi indizi, nascosti e sfacciatamente in vista, di quella storia incredibile fatta di intrighi e di dominio, di sapienze ermetiche e di scienze perfette, di alchimia e di riti antichi, la vera epopea di un progetto impossibile: la storia leggendaria della Cattedrale dei Walser, l'immensa “macchina spirituale” capolavoro dell'ignoto abate-cavaliere-alchimista, che in esso aveva profuso tutta la propria conoscenza e i propri legami di sangue e di potere; un progetto immane, mai eguagliato neppure, più di un secolo dopo, dalla celebre Rennes Le Chateau.
Per saperne di più
La vera storia di Ornavasso è stata minuziosamente riscoperta e ricostruita dall'autore di questo servizio. Vedi: www.francescoteruggi.com
Quando i frati scrutavano il cielo: monachesimo e astrologia
Nel celeberrimo Cantico delle Creature, il grande monaco santo Francesco d'Assisi (1181-1226) scriveva: “Laudato sie, mi' Signore, cum tucte le tue creature, spetialmente messor lo frate sole […] Laudato si', mi' Signore, per sora luna e le stelle, in celu l'ài formate clarite et pretiose et belle”.
Il testo poetico, di impareggiabile bellezza, è certamente anche un piccolo trattato “cosmologico” in cui, accanto ai quattro elementi (aria, acqua, terra, fuoco) declinati secondo animali e cose che a ciascuno appartengono, compaiono molti altri richiami, tra cui quello potente al cielo, nella tripartizione sole-luna-stelle.
Se il sole è quello che da la luce al giorno, la luna e le stelle sono “chiare”, non nel senso di “evidenti” ma di “pure” (contrario di “oscure” e “impure”) e “preziose”, irrinunciabili, necessarie. Sono insomma un vero “dono” divino. È la stessa “chiarezza” delle stelle alla quale pare proprio riferirsi anche il “Portale dello Zodiaco” della Sacra di San Michele, in cui compaiono gli unici elementi marmorei chiari dell'intero complesso abbaziale.
Molto meno velate sono invece le idee di un altro celebre monaco francescano, Ruggero Bacone (1214-1294), coevo del fondatore, che dedicò una parte della sua opera più celebre, l'Opus Major, all'esposizione delle sue teorie astrologiche a lungo studiate, vertenti sopratutto sull'influenza esercitata dai corpi celesti sulla mente e sullo spirito umani.
La quiete e il raccoglimento dei conventi, separati dalla società ma in essa pienamente immersi, come su un invisibile confine tra spirito e materia, favorì certamente lo studio e la ricerca anche in ambiti poco ortodossi del sapere, affrontati con lucida coerenza e senza i veli prodotti da troppa teologia o troppa ansia politico-religiosa. Uno di questi fu l'astrologia.
Tanto le ore del giorno, quanto le stagioni, i periodi e le mansioni dei confratelli erano rigidamente scanditi dai ritmi naturali. La data mobile della Pasqua e degli altri eventi liturgici ad essa collegati dovevano essere ricalcolate ogni anno e le chiese dovevano sempre essere orientate correttamente su fenomeni astronomici e sui loro corrispondenti significati astrologici. Tutto ciò comportava certamente, anche a detta degli storici, lo studio del moto delle stelle. I complessi abbaziali erano perciò spesso dotati di vere e proprie piattaforme di osservazione, balconate o terrazze dalle quali compiere tutte le necessarie misurazioni. Una è ancora visibile presso l'abbazia cistercense francese di Thoronet, in Provenza. Svetta sul doppio chiostro (due chiostri sovrapposti) come se la scansione delle volte e degli archi dei corridoi coperti fossero i punti di mira di un gigantesco sistema di osservazione.
Nella loro disposizione e orientamento, nella scansione degli ambienti che si aprono su ciascuno (di solito a est la sala capitolare e gli ambienti di studio; a sud refettori e cucine; a ovest dormitori e foresterie; a nord confinante con la chiesa abbaziale gli spazi per la “lectio divina”), nelle iconografie dei capitelli e degli archi e nelle loro geometrie, si ritrovano le indicazioni delle stagioni, dei moti planetari e dello zodiaco.
Già nell'antico Egitto i templi erano sempre dotati di un lago sacro, in genere quadrato che serviva anche per le osservazioni stellari. Il più celebre, quello di Karnak, ancora conserva, al centro di uno dei lati, una grande statua dello scarabeo sacro Khepri. Non solo è una divinità, è anche un segno zodiacale (Cancro) e corrisponde, secondo il computo del grande anno precessionale, al “quarto mese della gestazione”, cioè al 4300 a.C., epoca della prima unificazione del Regno sotto Menes!
Le sue dimensioni sono tali da poterlo chiaramente vedere da ogni punto del lago sacro, nelle cui acque si specchiavano i gruppi stellari e i pianeti.
Anche il tempio biblico di Salomone era dotato di un simile sistema di osservazione, molto probabilmente di origine egizia, installato proprio davanti all'ingresso. Veniva chiamato “mare di metallo fuso”, “mare di rame” o “mare di Brazen” ed era un gigantesco bacile metallico montato su 12 leoni a gruppi di tre, correttamente orientati (1Re:7 e 2Cronache:4). Si legge poi nel Libro dei Re che il bordo superiore era intervallato da 30 tori, chiara indicazione di un utilizzo astrologico.
Il chiostro monastico, con il pozzo d'acqua al centro nel quale si specchia la stella polare e i corridoi con le scansioni appropriate non è che il suo equivalente medievale, così come i monaci consacrati non furono che gli ultimi eredi di quei sacerdoti dei templi antichi che scrutavano gli astri.
Poiché le stelle e i pianeti erano spesso presenti, con le loro allegorie, nelle sacre scritture, l'analisi dei loro moti e dei cambiamenti che producono sull'essere umano non poteva che portare a riconoscervi la via divina da perseguire con ogni forza. Gli astri potevano fornire indicazioni non tanto sui tempi a venire, quanto su debolezze personali e mancanze caratteristiche che era necessario vincere per sperare in una maggior comunione con il divino.
Molti erano i monasteri che, insieme ad opere religiose, della patristica e dei teologi e sapienti, ospitavano nelle loro biblioteche anche trattati di astronomia e astrologia, pazientemente studiati e ricopiati dai meticolosi ammanuensi. Il “portale dello zodiaco” della Sacra di San Michele (Valsusa), ad esempio, fu concepito da “mastro nicholao” (forse il nome collettivo e simbolico della confraternita comacina autrice di quest'opera) prendendo ispirazione, come si racconta, da certi preziosi testi custoditi proprio nell'abbazia. Su due dei quattro lati di ciascun montante il magister non riportò semplicemente una teoria di simboli prelevati dalla tradizione astrologica (i 12 segni) e altrettanti simboli chiaramente identificati come costellazioni (accanto ad ognuna è inciso il suo nome), ma codificò in modo preciso tutta la sapienza che dietro questi segni si nasconde. Questo era uno degli scopi fondamentali del nuovo stile architettonico, conosciuto come “romanico”, sviluppatosi in ambito monastico (il fondatore è tradizionalmente Guglielmo da Volpiano, abate benedettino di Digione): rendere disponibile a chiunque ne fosse meritevole l'accesso alla conoscenza delle leggi divine, inserendola negli elementi scultorei, nei capitelli, nelle forme e nelle proporzioni e più tardi, negli affreschi, soprattutto absidali (innumerevoli sono gli esempi di tetramorfi con evangelisti e teorie dei mesi raffigurate attraverso le mansioni quotidiane e poi sostituite da schiere di apostoli). Il gotico con le grandi cattedrali ne avrebbe proseguita l'opera.
Anche fra le stelle era dunque possibile riconoscere la presenza e gli effetti della Divina Provvidenza e il monachesimo ne aveva fatto tesoro fin dall'inizio. Già nel V secolo tra i più grandi studiosi di astrologia figurava sant'Eucherio, vescovo di Lione e annoverato tra i Padri della Chiesa occidentale.

La sua formazione trentennale, dopo l'abbandono dei titoli e delle prerogative nobiliari della casata da cui proveniva, si era svolta nell'antico monastero isolano di Lerìns, fondato da un altro grande santo della Chiesa, Onorato. Fu proprio durante questo lungo periodo di raccoglimento che, studiando e scrivendo, Eucherio creò le sue maggiori opere, tra cui il Liber Formularum Spiritualis Intelligentiae, in cui affronta, fin dal liber unus, il tema dell'astrologia, concepito come una tra le “spiegazione di vari termini o modi di parlare della Scrittura”, spiegando il senso allegorico dei riferimenti a pianeti e costellazioni in relazione soprattutto al Libro dell'Apocalisse.
Così fa corrispondere l'ammasso delle Iadi alle anime dei santi predicatori, le stelle di Orione a quele dei martiri e le sette stelle dell'Orsa maggiore alle sette chiese e ai sette candelabri che simboleggiano la Chiesa Universale apocalittica.
In un testo successivo, i Commentarii in Genesim, per altro di dubbia attribuzione, specifica addirittura che le stelle del cielo sono gli Evangelisti e i dottori delle Sacre Scritture, che diffondono la luce divina illuminando la conoscenza umana.
Le idee di Eucherio non erano nuove, anzi, seguivano l'impostazione agostianiana. Il santo d'Ippona si era appassionatamente dedicato all'argomento, imponendosi subito come un suo detrattore. Ma a ben leggere, le sue riserve erano rivolte per lo più agli usi peccaminosi fatti della conoscenza delle stelle e dei pianeti, in particolare come mezzi per svelare e anticipare il futuro. Concepiva infatti gli astri come creazioni divine, nei quali era perciò possibile scorgere la benevolenza e la saggezza di Dio rivolta agli uomini.
Diversi secoli più tardi, un altro celebre monaco, il domenicano Alberto Magno, anch'egli vescovo e santo, cercando di riunire le posizioni dei suoi predecessori con l'impianto neoplatonico per cui tutto è emanazione di una “causa prima”, era un convinto assertore della dipendenza del mondo dai moti dei pianeti: "Nello studiare la natura non abbiamo a indagare come Dio Creatore può usare le sue creature per compiere miracoli e così manifestare la sua potenza: abbiamo piuttosto a indagare come la Natura con le sue cause immanenti possa esistere".
Il suo pupillo, Tommaso d'Aquino ne avrebbe riprese le idee: “I corpi celesti, come esercitano azioni l'uno sull'altro, così esercitano azioni anche sulla terra, e con l'azione esercitano anche un influsso. Ma poiché l'influsso è sulla materia, potrà essere esercitato sul senso, non sull'intelletto e sulla volontà, che sono essenze spirituali […]” (Summa Theologica, questione 115).
Intanto, nelle regioni europee più lontane, in cui meno l'ingerenza papale si faceva sentire, l'astrologia prosperava nei monasteri, dove veniva sempre più ampiamente studiata. Nel X secolo diventò celebre per il suo interesse verso le stelle, anche a scopo terapeutico, un monaco della comunità abbaziale di Mamelsbury, nel Wiltshire, “la più antica città inglese”: Oliviero (Eilmer), noto anche per essere stato uno dei primi a tentare il volo umano con ali posticce, cinque secoli prima di Leonardo.
Nello stesso periodo, poco più a nord, nel Wolchestershire, godeva di simile fama il priore di Malvern, Walcherio, di origini lotaringe, autore di precise osservazioni sulle eclissi solari e lunari occorse tra il 1091 e il 1092.
Questa è l'epoca della grande riscoperta dell'astrologia, durante la quale essa sembra riemergere dal silenzio del monasteri per diffondersi ovunque, sostenuta da molti pensatori anche laici del tempo e dai nuovi testi provenienti dal medioriente islamico conquistato dai crociati, soprattutto quelli di Avicenna e di Averroè, gli unici musulmani che, a detta di Dante, “possono seder tra filosofica famiglia”.
Protagonista di questi secoli è il beato Jan van Ruusbroec, “doctor admirabilis”, monaco fiammingo fondatore del monastero e della congregazione di Valverde (Groenendael), di ispirazione agostiniana. Grande cultore dell'astrologia, scrive diverse opere mistiche tra cui “I sette gradi dell'amore spirituale” e “L'ornamento delle nozze spirituali” in cui manifesta tutto il suo interesse per le stelle. Create da Dio per l'uomo, esse sono, secondo il beato, capaci di influire sul trionfo del bene o del male. Perciò anche l'anima umana, con i suoi vizi e le sue virtù, ne subisce l'intervento. Pianeti e astri indicano dunque la via della purificazione ascetica in quanto portano i vizi di cui l'uomo deve spogliarsi per rivestirsi della luce divina: "...il nostro padre celeste crea nel più intimo di noi stessi il firmamento interiore, purché noi siamo disposti a seguire la propensione naturale della nostra anima, ovvero la sinderesi inculcata ed impressa in noi da Dio, sempre, per sua natura, desiderosa del bene".
Nello stesso periodo è tutto un fiorire di opere di astrologia. L'Università del Galles, ad esempio, possiede nella sua collezione almeno una ventina di manoscritti redatti nei monasteri inglesi tra il XIV e il XV secolo, che trattano tutti gli aspetti della scienza medievale tra cui, in prima linea, proprio l'astrologia.
Tra tutti, il più famoso monaco astrologo fu però certamente Giovanni Tritemio (Johannes Tritemius, il cui vero nome era Johannes Heidenberg), abate benedettino di Sponheim e nell'ultima parte della sua vita, di Würzburg. Prolifico autore e studioso, nel fortunato periodo preconciliare in cui l'astrologia era arrivata ad interessare perfino il cardinale-teologo Pierre d'Ally (1350-1420) e addirittura papa Sisto IV (1414-1484) e papa Leone X (1475-1521), aveva avuto fra i suoi discepoli Lucio Cornelio Agrippa e Teofrasto Paracelso. Le sue opere erano intrise di ermetismo, riferimenti cabalistici, neoplatonismo e astrologia. A quest'ultima dedicò in particolare un testo, De septem secundeis id est intelligentiis sive spiritibus orbes post deum moventibus, una precisa trattazione della materia e dei suoi collegamenti con le altre discipline.
Ma era l'ultimo monaco che avrebbe potuto liberamente diffondere la conoscenza degli astri. Poco prima della sua morte già incombeva l'ombra minacciosa del concilio tridentino che presto si sarebbe tenuto e che avrebbe di nuovo gettato su di essa un velo di oscurità, lo stesso che ancora oggi permane e viene continuamente alimentato, talvolta dagli stessi eredi di quei monaci che, per paura ed egoismo, offendono e avviliscono la meravigliosa sapienza e la profonda spiritualità dei loro predecessori.
Questo articolo è disponibile in formato pdf su Academia.edu
BIBLIOGRAFIA
Bottin, Francesco (a cura di), Ruggero Bacone. La scienza sperimentale, Rusconi, Milano, 1990
De la Ville de Mirmont, H., L'Astrologie chez les Gallo-Romains in Revue des Études Anciennes. Tome 9, Maison de l'Archéologie - Université Bordeaux Montaigne, Pessac, 1907
Duhem, Pierre, Le système du monde. Histoire des doctrines cosmologiques de Platon à Copernic, Librairie scientifique A. Hermann et fils, Paris, 1913-1915
Kelley, David H. e Milone, Eugene F., Exploring Ancient Skies: A Survey of Ancient and Cultural Astronomy, Springer Science & Business Media, Berlino, 2011
Lawrence-Mathers, Anne e Escobar-Vargas, Caroline, Magic and Medieval Society, Routledge, London, 2014
Marra, Massimo, Il firmamento interiore del Beato Giovanni Ruysbroeck in Atrium - Centro studi umanistici e tradizionali anno VIII n°1, , 2006
Maxwell Woosnam, Eilmer, The Flight and The Comet, Friends of Malmesbury Abbey, Malmesbury, 1986
Page, Sophie, Astrology in Medieval Manuscripts, University of Toronto Press, Toronto, 2002
Schwaller de Lubicz, René Adolphe, Le Temple dans l'homme, Il Cairo, 1949 (Pubblicato in Italia con il titolo Il tempio dell'uomo, 2 volumi, Mediterranee, Roma, 2003)
Sorge, V. (a cura di) e Seller, F. (a cura di) Ruggero Bacone. Filosofia, scienza, teologia: dall'Opus maius, Armando, Roma, 2010
Thorndike, Lynn, History of magic and experimental science, Macmillan, New York, 1923


















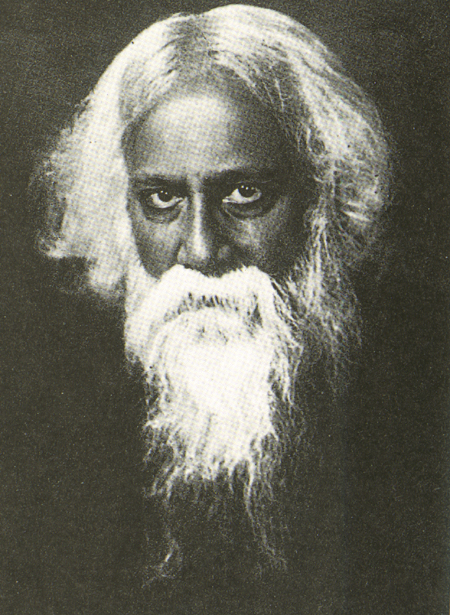 Deve essere lo scopo a cui tende tutta intera la nostra vita: in tutti i nostri pensieri e in tutte le nostre azioni dobbiamo avere la coscienza dell'Infinito.
Deve essere lo scopo a cui tende tutta intera la nostra vita: in tutti i nostri pensieri e in tutte le nostre azioni dobbiamo avere la coscienza dell'Infinito. Tu troverai più nei boschi che nei libri. Alberi e rocce ti insegneranno cose che nessun maestro ti dirà. Pensi forse che non potresti succhiare miele da una pietra né olio dalla roccia più dura? Non lasciano le montagne gocciolare giù dolcezza? Non sgorgano dai colli latte e miele? Sono talmente tante le cose che potrei raccontarti. Riesco a stento a trattenermi.
Tu troverai più nei boschi che nei libri. Alberi e rocce ti insegneranno cose che nessun maestro ti dirà. Pensi forse che non potresti succhiare miele da una pietra né olio dalla roccia più dura? Non lasciano le montagne gocciolare giù dolcezza? Non sgorgano dai colli latte e miele? Sono talmente tante le cose che potrei raccontarti. Riesco a stento a trattenermi.